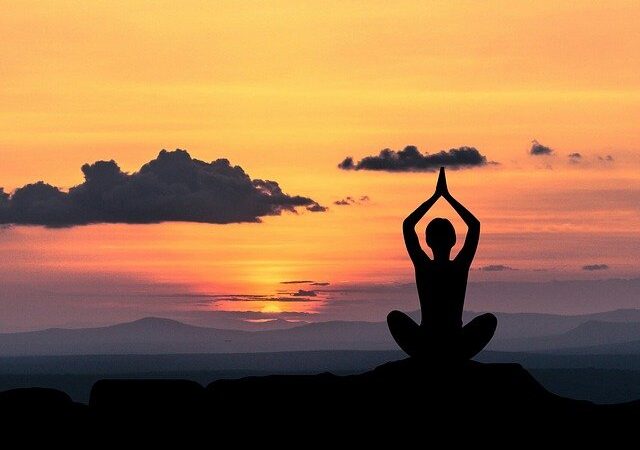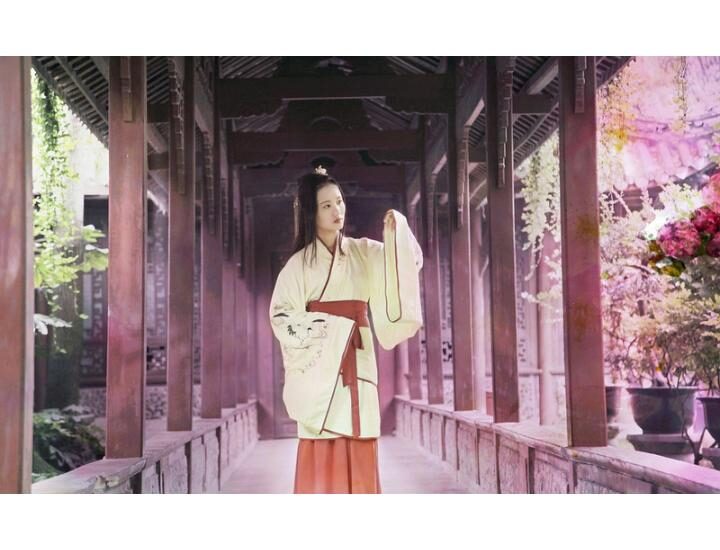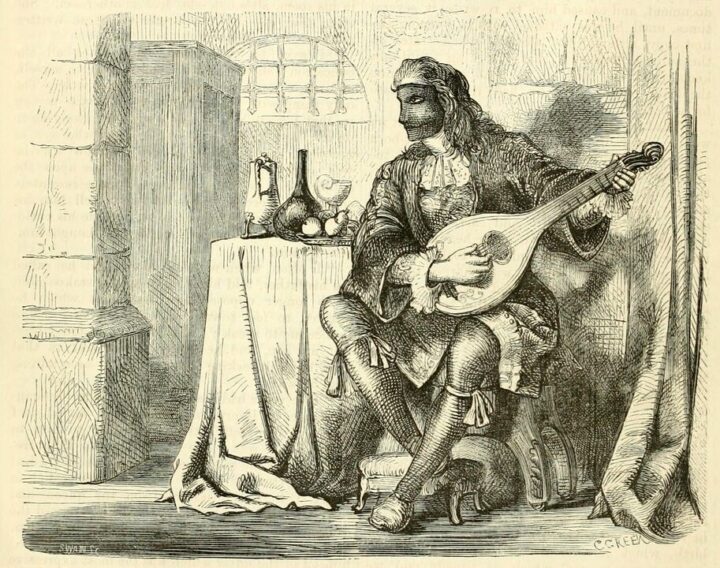«In medio stat virtus», «nel mezzo sta la virtù», è una frase che ha caratterizzato gli studi liceali di tutti e che anche solo per sentito dire aleggia nella memoria collettiva. Ma da dove deriva esattamente? Ad averla formulata precisamente è stata la filosofia Scolastica del Medioevo che ha ripreso una serie di principi dell’etica aristotelica, virandoli in una direzione teologica, tra i quali, appunto, quello della virtù come equilibrio tra eccesso e difetto. Di seguito, verrà illustrata la differenza che intercorre tra la concezione della virtù nel mezzo dell’etica del filosofo greco e quella della Scolastica medievale.
L’Etica Nicomachea di Aristotele
Il pensiero etico di Aristotele è trattato principalmente nella sua opera L’Etica Nicomachea, dove esprime chiaramente la sua idea di cosa sia la virtù. Innanzitutto, il filosofo si chiede quale sia lo scopo della vita dell’uomo e trova la risposta nell’esercizio di un bene supremo: un bene fine a sé stesso che non miri a soddisfare un proprio bisogno particolare ma quello di una comunità. A questo punto, Aristotele prosegue sostenendo che ciò che permette di arrivare a raggiungere ed a mettere in atto tale bene supremo è la politica, ovvero quella scienza che consente di ricercare un bene che non sia improntato ad un certo particolarismo, ma che sia rivolto all’intera città. Così, l’essere umano può conseguire la felicità, l’εύδαιμονία, che secondo lo stagirita consiste nell’esercizio della virtù. La felicità, dunque, per Aristotele non si trova nella ricchezza, nel piacere o, in generale, nell’attaccarsi ai beni materiali ma è individuabile in una concezione più alta: la virtù è specchio di ciò che si consegue con la ragione, si trova esattamente nel giusto mezzo tra i due poli dell’eccesso. Da qui, appunto, si costruisce il senso della frase esaminata, «In medio stat virtus», che indica il conseguimento di un equilibrio secondo la ragione.
«In medio stat virtus» nella Scolastica medievale
Il termine Scolastica indica, in generale, la filosofia e la teologia Medievali. Il termine fu introdotto e usato solo dagli umanisti per designare in modo dispregiativo un’espressione del pensiero fin troppo inutilmente meticolosa e di difficile comprensione, nonché totalmente asservita alla teologia. Sicuramente, si può definire la Scolastica una filosofia prevalente nelle scuole del Medioevo e cristiana, ma non perché tratti esclusivamente di questioni relative alla fede, bensì nel senso che in un’ottica in cui la verità e la sua rivelazione provengono dalla stessa fonte, essa non può essere contraddetta da altre scienze.
Al suo interno, però, il panorama appare assai variegato e le sue caratteristiche si diversificano in base a ciascun filosofo. Eppure, nonostante ciò, si può riscontare una certa matrice comune proveniente dalla filosofia di Aristotele in particolare per quanto concerne la virtù, tant’è che l’espressione «In medio stat virtus» così come la si legge è stata coniata dagli esponenti della Scolastica medievale. L’obiettivo di quest’ultima non è quello di indagare a cosa corrisponde la verità, ma è quello di comprenderla e rivelarla, essendo la verità già data dalle Sacre Scritture. Tale rivelazione era prerogativa dei maestri nelle scuole medievali che dovevano spiegare la verità con l’utilizzo della ragione e dimostrarla attraverso le fonti antiche. Proprio per ciò, il punto di contatto con i classici della filosofia greca e di quella, appunto, aristotelica è l’utilizzo della ragione, pur essendo virata in questo caso nel campo della fede. Allora, anche qui la virtù diventa sinonimo di equilibrio tra eccesso e difetto, ma in questo caso «In medio stat virtus» non significa più la ricerca di una felicità riconoscibile in un bene politico supremo per la comunità. «In medio stat virtus», infatti, si colora di uno sfondo teologico, dove quella dimensione nella quale si utilizza la ragione diventa comunione con la verità metafisica già data e valida, che ha bisogno solo di essere riconosciuta.
Fonte immagine di copertina: Pixabay