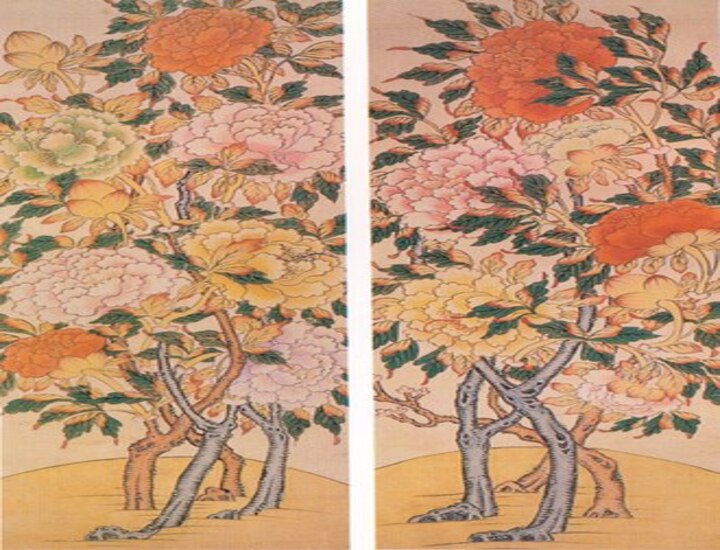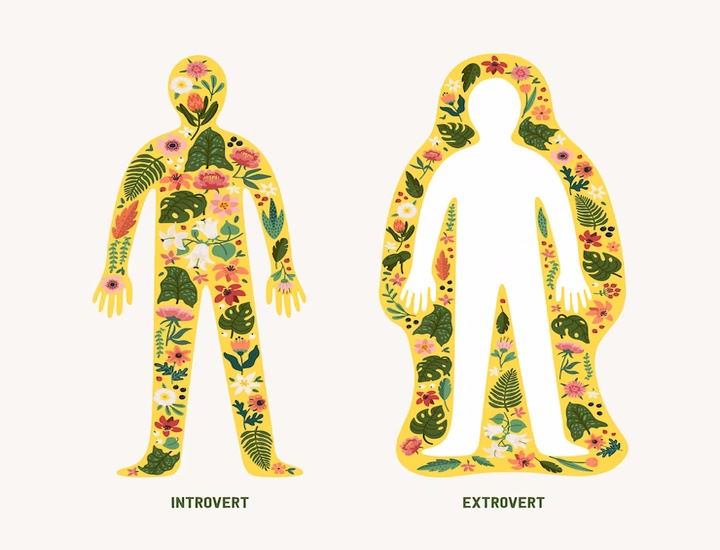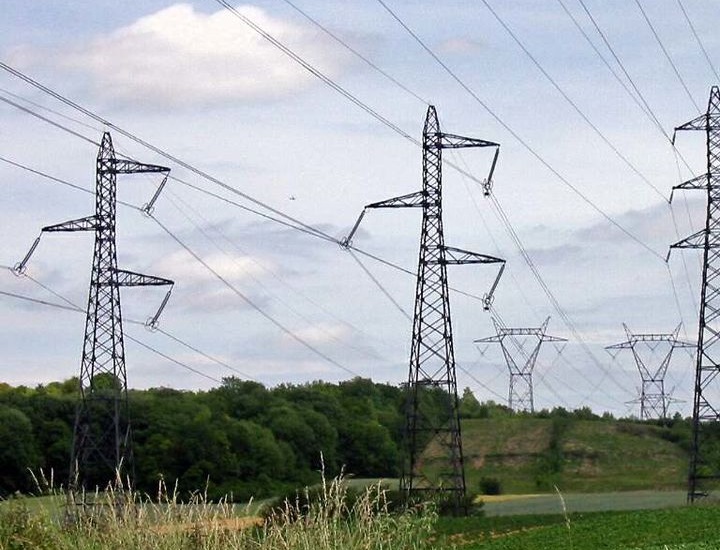Il lungo periodo di ripresa economica iniziato nell’XI secolo, caratterizzato da un deciso aumento della popolazione e della produzione agricola, dalla rinascita delle città e dallo sviluppo dei commerci locali e internazionali, si arrestò tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo, quando l’Europa entrò in una fase di recessione definita comunemente con l’espressione crisi del Trecento.
È impossibile individuare un unico fattore determinante di questa inversione di tendenza, per la quale occorre invece considerare un insieme di cause, fortemente correlate le une alle altre e che affondavano le loro radici nelle debolezze strutturali del sistema socioeconomico feudale. Infatti, dai decenni finali del Duecento, la produzione agricola non riusciva più a rispondere alle esigenze alimentari di una popolazione in costante crescita da ormai tre secoli, e per di più concentrata nelle città, che dipendevano totalmente dal contado per il loro approvvigionamento. Le terre coltivabili, che in precedenza erano state estese soprattutto a danno di pascoli e foreste, terreni già di per sé non molto fertili, erano esaurite; inoltre, in mancanza di sostanziali innovazioni nelle tecniche agricole, le rese delle colture erano rimaste piuttosto basse.
Alla sproporzione tra risorse economiche disponibili e pressione demografica si aggiunse un peggioramento delle condizioni climatiche in tutta Europa, con gravi ripercussioni sulle campagne. Qui, a partire dal biennio 1315-1317, si registrò una serie di cattivi raccolti e di prolungate carestie, che determinarono un forte rialzo dei prezzi dei cereali, elemento base dell’alimentazione, e una conseguente situazione di fame generalizzata per chi non disponeva di grandi risorse economiche, scaturendo quindi nella crisi del Trecento. Pertanto, la popolazione, e in particolar modo i ceti più svantaggiati, fortemente indeboliti nelle difese immunitarie dalla denutrizione e quindi maggiormente esposti a malattie, subì un deciso calo. Masse di contadini abbandonarono le campagne, per cercare nei centri urbani opportunità di sopravvivenza. In tal modo, alcune regioni europee si spopolarono quasi completamente: ad esempio, nell’ Italia centro-meridionale e insulare quasi il 50% degli insediamenti umani del contado scomparve e gran parte delle terre lasciate incolte fu invasa da sterpaglie o foreste.
Il crollo demografico e la reazione alla peste nel corso della crisi del Trecento
Sulle popolazioni già provate dalla fame e concentrate nei centri urbani, dove si viveva in abitazioni spesso precarie e in condizioni igienico-sanitarie molto carenti, alla metà del XIV secolo si abbatté, oltre alla cosiddetta crisi del Trecento, anche il terribile flagello della peste, che investi l’intero continente europeo, risparmiando soltanto alcune aree assai limitate, tanto da far parlare di una vera e propria pandemia. Nel corso del Trecento, in Europa la peste divenne una malattia endemica: infatti, si ripresentò con frequenza abbastanza regolare, fino al XVIII secolo avanzato, quando si registrarono gli ultimi focolai. È per questa ragione che il continente visse un vero e proprio crollo demografico, che perdurò fino alla metà del Quattrocento. Il perdurare del deficit demografico fino all’avanzato XV secolo è comunque da ascrivere anche alle guerre. Queste, infatti, furono particolarmente numerose nel Trecento e nel Quattrocento ed ebbero un effetto devastante sia sulle condizioni di vita delle popolazioni civili sia sul territorio.
Viste le scarse conoscenze mediche del tempo, i contemporanei non erano in grado né di spiegare le modalità di trasmissione della peste né di opporvi rimedi efficaci. Le autorità civili, dunque, si limitarono generalmente ad adottare misure di emergenza, come le quarantene, al fine di limitare il più possibile la propagazione della malattia. L’impatto psicologico esercitato dal morbo sugli individui durante la crisi del Trecento fu enorme: esso, inducendo a comportamenti antisociali provocati dalla paura, infrangeva i legami familiari, paralizzava la vita delle comunità, alterava i normali rapporti umani. Fu così che, nel panico collettivo, la cultura popolare additò la causa dell’epidemia soprattutto nei peccati degli uomini e nella corruzione della cristianità, che avevano scatenato la collera di Dio. Per questa ragione, il clero mobilitò i fedeli affinché si intensificassero le pratiche devozionali e si rivolgessero culti particolari a santi taumaturghi, ritenuti capaci di scongiurare il flagello della peste, come san Rocco. Un’altra tipica manifestazione dell’isteria che dominava la popolazione fu il movimento dei flagellanti, penitenti che si spostavano in processione per le città dell’Europa centro-occidentale mortificando il proprio corpo attraverso la fustigazione, nella convinzione che tali atti di pubblico pentimento servissero a ottenere il perdono divino e a placare la peste. Legata in parte al fenomeno dei flagellanti è anche la recrudescenza dell’antigiudaismo cristiano: infatti, di fronte all’evidente inefficacia dei riti penitenziali, molto spesso i flagellanti fomentavano le comunità locali contro gli ebrei, ritenuti responsabili di diffondere il contagio e dunque fatti oggetto di violente persecuzioni.
Fonte immagine per l’articolo sulla crisi del Trecento: Wikipedia