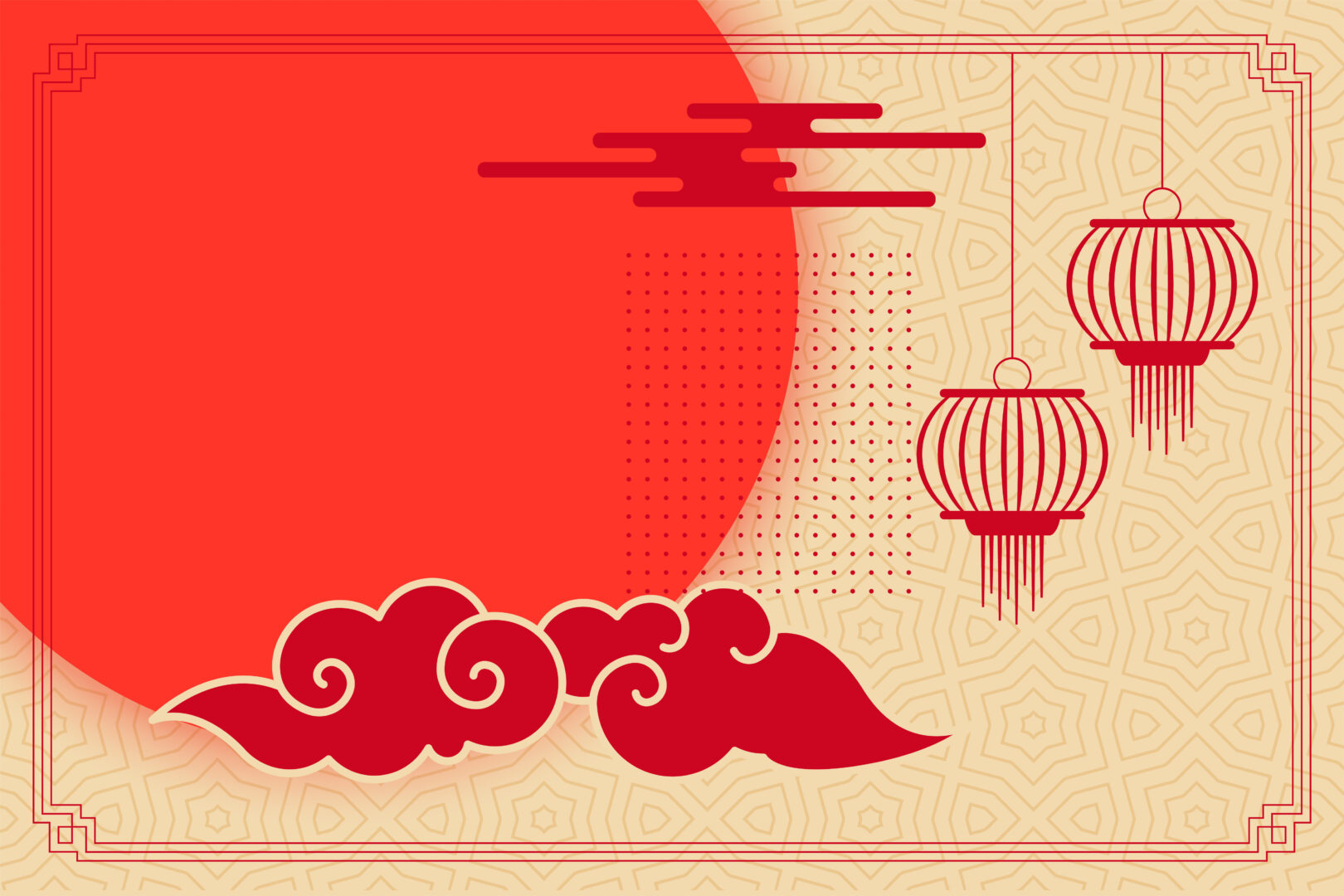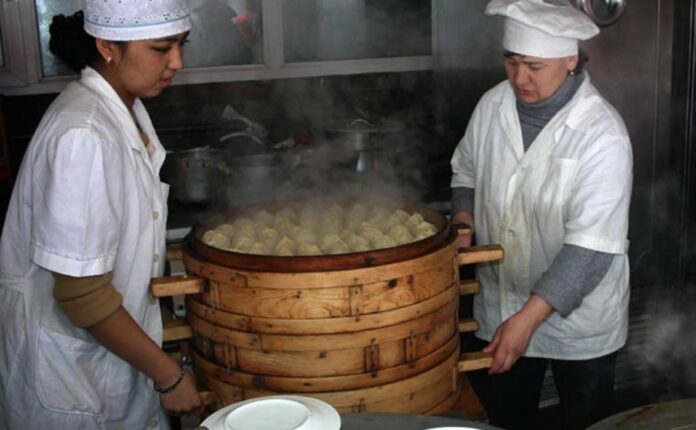Il Mito della Biga Alata: l’anima secondo Platone
Il Mito della Biga Alata, narrato da Platone nel *Fedro*, rappresenta una delle più affascinanti e suggestive allegorie della filosofia platonica. Attraverso l’immagine di un carro trainato da due cavalli e guidato da un auriga, Platone descrive la natura complessa dell’anima umana, il suo viaggio verso la conoscenza e il suo destino. Questo mito, noto anche come Mito del carro e dell’Auriga, è uno strumento letterario con cui Platone chiarisce la sua concezione di anima. Per gli appassionati di mitologia greca, la stessa che affonda le proprie radici anche nella filosofia platonica, il Mito della Biga Alata è sicuramente uno dei racconti più affascinanti. Il mito, infatti, si inserisce in una più ampia riflessione sull’ontologia, sull’epistemologia e sull’etica, offrendo una visione del mondo e dell’uomo che ha profondamente influenzato il pensiero occidentale. Platone utilizza la metafora del carro per spiegare il percorso dell’anima nel mondo delle idee. In particolare, si concentra sul concetto di reminescenza, per spiegare l’origine della conoscenza.
Il Fedro di Platone: contesto e introduzione al Mito della Biga Alata
Il *Fedro*, scritto presumibilmente intorno al 370 a.C., è un dialogo platonico che affronta diversi temi, tra cui la bellezza, l’amore, la retorica e la natura dell’anima. All’interno di quest’opera, il Mito della Biga Alata occupa un posto di rilievo, in quanto offre una rappresentazione vivida e simbolica della concezione platonica dell’anima.
Socrate e Fedro: un dialogo sulla natura dell’anima
Il dialogo si svolge tra Socrate, maestro di Platone, e il giovane Fedro. I due si incontrano fuori dalle mura di Atene e, dopo aver discusso di retorica, affrontano il tema dell’anima. Per spiegare la sua visione, Socrate ricorre al Mito della Biga Alata, un’allegoria che illustra la natura dell’anima e il suo rapporto con il mondo sensibile e il mondo intelligibile, il mondo delle idee.
Il Mito della Biga Alata: la rappresentazione dell’anima
Nel mito, l’anima umana è paragonata a una biga alata, un carro trainato da due cavalli, uno bianco e uno nero, e guidato da un auriga. Questa immagine rappresenta la natura tripartita dell’anima, secondo la concezione platonica.
La biga: simbolo dell’anima tripartita
La biga, ovvero il carro, rappresenta l’anima nella sua interezza. Secondo Platone, l’anima è composta da tre parti: la parte razionale, quella concupiscibile e quella irascibile. Queste tre parti sono in costante interazione e conflitto tra loro, determinando il comportamento e il destino dell’individuo. Il concetto di anima tripartita ricorre anche nel Mito della caverna e nel Mito di Er.
I due cavalli: la parte razionale e irrazionale dell’anima
I due cavalli simboleggiano le due componenti dell’anima che si contrappongono alla ragione: il cavallo bianco rappresenta la parte irascibile, la forza d’animo, il coraggio, l’elevazione al mondo delle idee, la ricerca della raffinatezza e del bello, in sostanza, la componente razionale dell’anima; il cavallo nero rappresenta la parte concupiscibile, i desideri, gli impulsi, gli istinti e l’irrazionalità. Quest’ultimo, con la sua natura ribelle, tende a trascinare la biga verso il basso, verso il mondo sensibile e le sue tentazioni, anche per abbreviare il viaggio nell’Iperuranio e compiere la reincarnazione. Il cavallo bianco, al contrario, aspira a innalzarsi verso il mondo delle idee, verso la verità, la bellezza e la giustizia.
L’auriga: la guida dell’anima
L’auriga rappresenta la parte razionale dell’anima, la ragione, che ha il compito di guidare la biga e di tenere a bada i due cavalli, cercando di indirizzarli verso l’alto, verso l’Iperuranio, verso la contemplazione delle idee. Il compito dell’auriga è arduo, in quanto deve riuscire a bilanciare le forze contrastanti dei due cavalli, uno nobile e obbediente, l’altro recalcitrante e indisciplinato. In particolare, deve spronare i cavalli verso la volta celeste, in modo che possano raggiungere l’elevazione spirituale. In base alla sua capacità di direzionare i cavalli, l’auriga determinerà il destino dell’anima stessa.
Il viaggio nell’Iperuranio: il destino dell’anima
Secondo Platone, le anime, prima di incarnarsi in un corpo, compiono un viaggio nell’Iperuranio, un “luogo non-luogo” al di là del cielo, dove risiedono le idee, forme perfette ed eterne di cui le cose del mondo sensibile sono solo copie imperfette. L’Iperuranio è il luogo della raffinatezza, della ricchezza interiore e, dunque, per i greci il bello più puro.
Il cavallo bianco: l’ascesa verso il mondo delle idee
Il cavallo bianco, con la sua indole nobile, tende naturalmente verso l’alto, verso l’Iperuranio, e aiuta l’auriga nel suo compito di guidare la biga verso la contemplazione delle idee. Anche le anime degli dei hanno i cavalli, ma sono esclusivamente bianchi e non hanno alcuna difficoltà nel raggiungimento dell’Iperuranio.
Il cavallo nero: l’ostacolo all’elevazione spirituale
Il cavallo nero, al contrario, con la sua natura impulsiva e desiderante, ostacola l’ascesa della biga, cercando di trascinarla verso il basso, verso il mondo sensibile. Le bighe umane hanno difficoltà, in quanto i cavalli neri tendono a correre nella direzione opposta, dunque si corre il rischio che le ali dei cavalli possano spezzarsi e la biga possa cadere sulla terra, dando luogo all’incarnazione.
La caduta e la reincarnazione: reminiscenza e conoscenza innata
Se l’auriga non riesce a controllare il cavallo nero e a mantenere la biga in volo, l’anima precipita sulla terra e si incarna in un corpo, dimenticando le idee che ha contemplato nell’Iperuranio. Secondo Platone, la conoscenza è quindi reminescenza (o anamnesi), un ricordo delle idee che l’anima ha contemplato prima di nascere. Una volta incarnata, l’anima porta con sé la reminiscenza di quelle idee nel corpo umano. Esse rappresentano la conoscenza innata, la verità di quella persona. Dunque, più a lungo sarà rimasta nel mondo delle idee, più reminiscenze avrà.
Mito della Biga Alata: interpretazione e significato
Il Mito della Biga Alata è un’allegoria complessa e ricca di significati. Esso illustra la concezione platonica dell’anima, divisa tra una componente razionale e una irrazionale, e il suo dualismo anima-corpo. Il mito sottolinea l’importanza della ragione come guida delle passioni e degli istinti, per raggiungere la conoscenza e la saggezza. Inoltre, esso introduce il concetto di metempsicosi, ovvero la trasmigrazione delle anime, un tema fondamentale della filosofia platonica.
Fonte immagine di copertina: Wikipedia