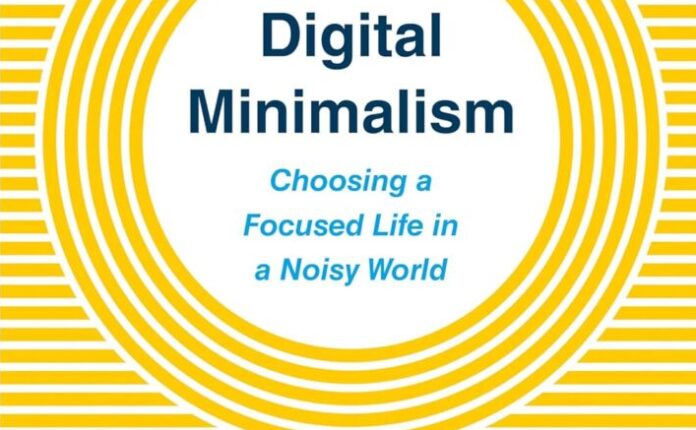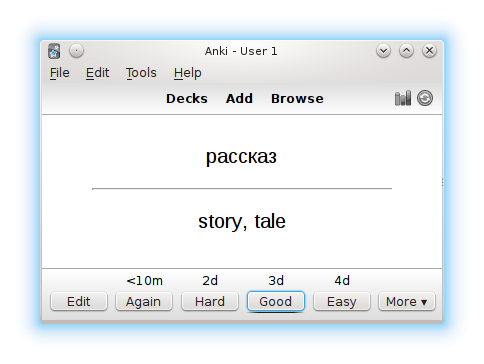I concetti di sfruttamento e solidarietà secondo Seneca e Menandro: il Misantropo e Epistulae ad Lucilium.
Menandro, Il Misantropo. Vv. 711-714. «Né forse (…), né uno, qualcuno di voi, potrebbe dissuadermi al riguardo, ma sarete d’accordo. Forse sbagliai una sola cosa; credevo di essere io stesso qualcuno autosufficiente e di non aver bisogno di nessuno in futuro».
La fase del IV-III secolo a. C. della produzione comica rifletteva il cosmopolitismo successivo al dominio macedone e portava in scena temi universali: l’instabilità della fortuna, l’amicizia, la solidarietà, i conflitti familiari. L’autore più rappresentativo di questo periodo è l’ateniese Menandro, allievo di Teofrasto, successore di Aristotele e autore dei Caratteri, una sorta di summa degli svariati profili psicologici e sociali presenti nel panorama contemporaneo. Intatta quanto a forza comica e vivacità espressiva rispetto alla commedia antica aristofanesca, la commedia nuova di Menandro se ne differenzia in un punto fondamentale: mentre nelle opere di Aristofane è centrale la difesa della polis, della superiorità etica e politica di Atene, in quelle di Menandro il destino della Grecia, ormai segnato, perde del tutto d’importanza.
Non contano più strategie, decisioni, risoluzioni favorevoli o sfavorevoli alla collettività, percepite alla stregua di eventi superumani, che si scatenano come le tempeste e proprio come le tempeste vanno sopportati; tutto quel che ha importanza comincia e finisce con la vita quotidiana degli uomini, con il loro lavoro, la loro vita personale, la loro scala di valori morali.
In cosa consistono, dunque, i concetti di sfruttamento e solidarietà secondo Seneca e Menandro?
La commedia in esame è incentrata sul concetto di solidarietà, espresso tramite il carattere del misantropo, Cnemone nel testo, un vecchio contadino abituato alla dura fatica «che è capace di ostinarsi sulla roccia che dà timo e salvia soltanto e di ricavarne nient’altro che travagli». Il vecchio arcigno vive a File insieme alla figlia e a Simiche, isolato da tutti ed alienato dalla società. Cnemone vive separato perfino dalla moglie che, stanca del suo carattere intrattabile, è andata a vivere con Gorgia, il figlio che ha avuto dal suo primo marito. Sostrato, figlio di un ricco che abita in città, si è innamorato della figlia dell’arcigno al solo vederla; dopo varie peripezie e grazie all’aiuto di Gorgia, il giovane riuscirà a coronare il suo sogno d’amore. Sostrato, inoltre, sarà in grado di cambiare l’atteggiamento del padre Calippide nei confronti di Gorgia, povero ma generoso; l’uomo finirà con l’acconsentire a un doppio matrimonio all’interno della sua famiglia: Sostrato sposerà la figlia di Cnemone, Gorgia convolerà a nozze con la sorella di Sostrato. Alla fine della commedia Cnemone cambia non tanto modus vivendi, piuttosto modella il proprio atteggiamento nei confronti degli altri esseri umani, non più accomunati da un uguale rifiuto e ostilità ma valutati secondo i loro stessi comportamenti. Menandro concentra il concetto di solidarietà soprattutto nella scena in cui Cnemone viene salvato da Gorgia e capisce di aver sbagliato a giudicare indifferentemente tutti in modo negativo, riconciliandosi in parte con il mondo degli uomini. A Gorgia affiderà poi anche la figlia.
I personaggi, al di là dell’origine sociale o del loro status economico, risultano felicemente vincenti nella commedia dopo aver condotto battaglie per eliminare la grettezza egoistica e meschina. Sostrato sostiene infatti che «finché si possiede la ragione, non bisogna mai disperare di nulla», in qualche modo contrapponendo un tale modo di vivere con quello dissennato e fuori dagli equilibri sociali e psichici di Cnemone, più volte appellato nella commedia come un pazzo, incattivito dalla povertà e sfiduciato dalle azioni opportunistiche e calcolatrici degli uomini. I dolori esistenziali aggravati dalla povertà castrante cessano o si addolciscono grazie alla philantropìa, la «social catena» presente ne La ginestra del Leopardi, che risolve le fratture sociali e umane nell’universo disegnato da Menandro, convinto che l’uomo sia piacevole quando esprime pienamente le sue schiette e nobili doti umane e dando prova di una fiducia aperta all’ottimismo nelle capacità dell’uomo. Al centro della commedia di Menandro, quindi, vi è l’uomo con i suoi piccoli e grandi drammi quotidiani che si approccia al mondo con sensibilità e finezza di modi anche quando non è di estrazione sociale elevata, perché quello che conta sono i sentimenti, non il denaro o il potere. La struttura dell’opera risulta fortemente classicheggiante: vi è una situazione iniziale che ad un certo punto viene sconvolta dall’intervento della divinità che, in questo caso, fa innamorare Sostrato della figlia di Cnemone.
Il finale è caratterizzato dallo scioglimento delle difficoltà della vicenda, in cui viene premiata la tenacia e la virtù e viene corretto il cattivo vizio. Tuttavia, Il Misantropo è stato scritto in un’epoca in cui Menandro era ancora molto giovane e alle prime armi, di conseguenza egli non è riuscito completamente a fondere gli aspetti comici con il vero significato della commedia. C’è da dire che comunque i protagonisti, Cnemone e Sostrato, spiccano in tutta la vicenda per la finezza con la quale l’autore riesce a descriverli, mettendo in luce l’amore del giovane, disposto a qualunque cosa pur di conquistare la sua amata, e il triste isolamento in cui il vecchio vive, infastidito dall’avidità e l’egoismo della gente che lo circondava, in particolare i ricchi. Privato di un contesto che ne trascende l’individualità, non più considerato un simbolo, l’uomo di Menandro è il singolo, quel che la modernità apostrofa come uomo comune o uomo qualunque; in una parola, l’esatta proiezione (altro termine moderno) del pubblico cui le sue commedie sono destinate. L’uomo misura di tutte le cose del sofista Protagora è dunque anche l’uomo di Menandro, la misura della sua arte.
Quanto allo stile, l’opera non rispecchia minimamente Aristofane, il quale abbraccia uno stile ricco di parolacce e di termini volgari che gioca sul duplice significato delle parole. Menandro non ha infatti quest’esigenza: egli porta sulla scena la classe borghese e la classe media ateniese. Menandro usa un linguaggio medio: né aulico, che sarebbe parodistico per la commedia, né quello di Aristofane, troppo volgare. Aristofane modellava la lingua a seconda dei personaggi; Menandro adotta uno stile medio, un po’ elegante, né troppo alto né troppo basso, che però si priva della possibilità di suscitare la risata. Quando parliamo dei concetti di sfruttamento e solidarietà secondo Seneca e Menandro, nella commedia troviamo solamente degli schiavi che coloriscono l’ambiente, i quali però non sono i personaggi portanti, pertanto non vi è un approfondimento sul tema dello sfruttamento in questo caso. Perché l’uomo possa identificarsi con il personaggio, Menandro presenta personaggi che potrebbero essere gli spettatori ed eventi credibili che possono succedere, in modo che il pubblico possa trarre conforto dal risultato positivo.
Seneca, Epistulae ad Lucilium. XLVII, 3 «…Ma agli infelici schiavi non è consentito muovere le labbra nemmeno in ciò per parlare; ogni mormorio è punito con la frusta, e neppure i rumori involontari sono esenti dai colpi: la tosse, gli starnuti, il singhiozzo; il silenzio interrotto da una qualche voce è pagato con una grande punizione. Tutta la notte restano digiuni e muti».
Quando parliamo dei concetti di sfruttamento e solidarietà secondo Seneca e Menandro è doveroso menzionare l’Epistola 47 di Seneca, una tra le opere più famose, interamente dedicata al problema della schiavitù. Felicitandosi con l’amico Lucilio, che invece adotta un atteggiamento umano e familiare con i propri schiavi, Seneca condanna aspramente il rapporto che coesisteva allora tra padrone e schiavo, ovvero un rapporto di assoluta subordinazione, mentale e fisica. A parte il capriccio del caso, sostiene il filosofo, tra liberi e schiavi non vi è alcuna differenza: anche i secondi sono esseri come noi, respirano la stessa aria, vivono, muoiono come tutti gli altri e vanno trattati da uomini in quanto tali. Ma allora com’è possibile che un uomo schiavizzi un altro uomo? Come fa a guardarlo negli occhi come se niente fosse? A tali domande non esiste una risposta assoluta, anzi; proprio a causa di ciò, sostiene Seneca, vengono a mancare la morale, l’eticità e il rispetto; dogmi senza i quali l’uomo diviene padrone dell’uomo come se quest’ultimo fosse un oggetto, un possesso, un corpo privo di sensibilità, di emozioni, di idee e sentimenti. Cosa intendiamo, dunque, quando parliamo dei concetti di sfruttamento e solidarietà secondo Seneca e Menandro?
Cos’è realmente la libertà secondo Seneca?
Per Seneca, come del resto per gli Stoici, il concetto di libertà si identifica con il concetto di liberazione da tutte le forme di schiavitù che opprimono l’interiorità dell’uomo e da tutto ciò che impedisca all’uomo lo svilupparsi libero della propria volontà, cioè l’autodeterminazione. La libertà della persona, a partire da Epitteto e Marco Aurelio, diviene un dogma: occorre insegnare, dunque, come conservare tale libertà, uno dei beni fondamentali della vita. Per raggiungere tale stato è necessario crearsi un criterio di giudizio e distinzione tra bene e male, senza lasciarsi influenzare dall’ambiente circostante: fin quando nell’uomo non esisteranno ben chiari tali valori, egli si farà trascinare dalle passioni, senza che la ratio riesca a indicargli la via per la liberazione auto-centrica.
Lo stoicismo però non si soffermò mai tanto esplicitamente sul tema della schiavitù. Originale e meritorio appare dunque il fatto che Seneca si occupi di schiavitù in tutta la sua opera, anche prima della Epistola 47, con una sensibilità che spesso lo avvicina a quella del nascente Cristianesimo. Un accenno significativo del De Clementia illustra l’atteggiamento del saggio verso l’umanità, inclusi gli schiavi: «Mentre, rispetto a uno schiavo, tutto è lecito, vi sono però cose che il diritto comune agli esseri animati proibisce di rendere lecite contro gli uomini». I capitoli 17-28 del De beneficiis sostengono poi la tesi secondo cui non solo un uomo libero può rendere un beneficio a uno schiavo, ma reciprocamente uno schiavo, con un beneficio, può legare a sé sul piano dell’humanitas un uomo libero. Bisogna comunque ricordare che a Roma si era via via affermata una tradizione di mitezza verso gli schiavi. Secondo Seneca, però, un altro modo per essere liberi risiede nel rifuggire la folla.
Egli afferma quanto sia necessario evitare il contatto con la folla: d’altra parte, egli non vuole delineare la figura di un saggio eremita, in fuga da ogni responsabilità, ma vuole preservare l’autonomia spirituale dell’uomo, quindi aiutarlo nella conquista della propria interiorità. Chi vuole essere felice, dunque, deve appartarsi, fuggire la moltitudine ed anche le poche persone, anche una sola persona se la sua compagnia è più pericolosa della solitudine. Nell’Epistola 10 Seneca arriverà ad affermare che, talvolta, è meglio frequentare solo se stessi. Quanto allo stile, Seneca stravolge e rivoluziona la prosa latina: egli passa dall’armoniosità del periodo ciceroniano ad una prosa con periodi asimmetrici, con frasi semplici ed essenziali, facilmente memorizzabili; se con Cicerone parliamo di concinnitas, con Seneca si attua invece la brevitas e l’inconcinnitas. Nell’opera senecana prevale la paratassi sull’ipotassi, un importante e fondamentale uso della coordinazione.
Seneca fa parte della scuola asiatica, la quale però non è la stessa di Cicerone: egli frequenta la scuola asiatica moderna di età imperiale ove abbondano le figure retoriche, tra cui la metafora, le antitesi, le ellissi, l’anafora, il chiasmo ed i neologismi. Presente è anche la variatio, ripresa proprio dall’Arpinate, ovvero l’alternare parole simili affinché la frase possa essere più semplice da assimilare e memorizzare. Si prenda ad esempio la famosa «Vindica te tibi», incipit dell’Epistola 1, nella quale troviamo frasi brevi, come lo stesso titolo: queste sono sentenze riguardanti lo scorrere del tempo, il tema della morte, la vita intesa come denaro, indirizzate tutte ad un interlocutore ideale, a cui Seneca dà il nome di Lucilio. Il bello di Seneca è che ogni concetto divulgato viene ripreso diverse volte affinché questo sia chiaro al lettore.
In conclusione, potremmo dire che i concetti di sfruttamento e solidarietà secondo Seneca e Menandro fanno fede, per il primo, ad un elemento insito e proprio di ogni uomo che sta tutto in quella summa di azioni genuine fatte per aiutare l’altro; per il secondo lo sfruttamento è invece un concetto inaccettabile che sdegna l’uomo riducendolo ad una mera macchina pronta a soddisfare i bisogni di coloro che, essendo nati in condizioni più favorevoli e agiate, si elevano al di sopra di essa. Il messaggio fondamentale della lettera è che non bisogna giudicare l’uomo dalle circostanze esteriori, ma dalla sua indole. Seneca mostra, inoltre, come il concetto di schiavitù debba essere interiorizzato: si può essere schiavi delle proprie passioni o di un’altra persona pur essendo liberi per condizione sociale; viceversa, si può avere un animo libero pur essendo schiavi.
Fonte immagine in evidenza: Freepik