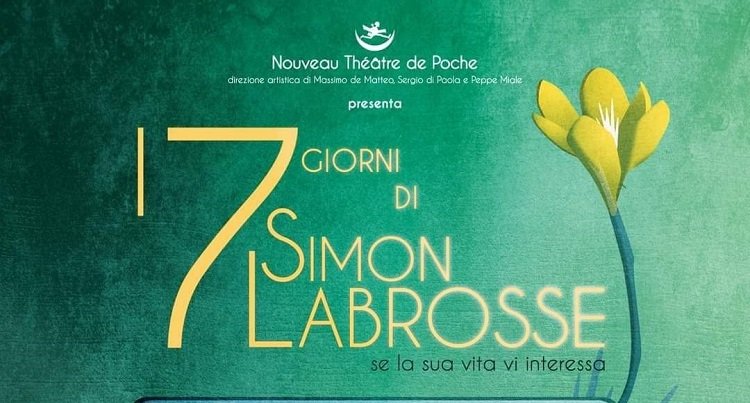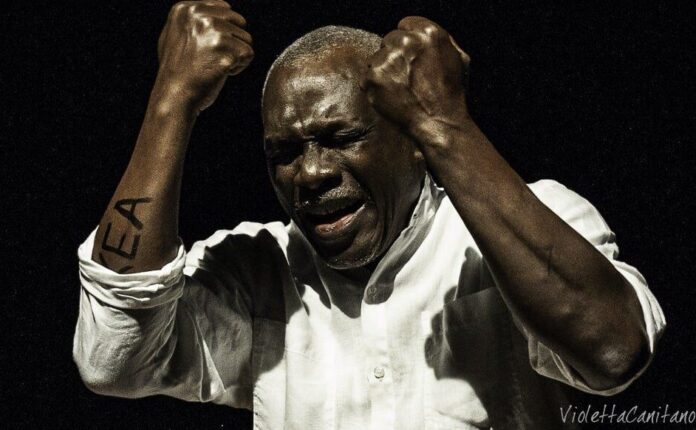I sette giorni di Simon Labrosse al Théatre de Poche
Un piccolo teatro situato nei sotterranei di Napoli, ma uno spazio ardente dove brulicano drammaturgie classiche e contemporanee e laboratori di recitazione, il Théatre de Poche è un centro attivo e appassionato nel cuore della città, precisamente nella zona di Materdei. Presenta orgogliosa la sua nuova produzione con lo spettacolo I sette giorni di Simon Labrosse, un’opera teatrale tratta senza troppe modifiche dalla drammaturgia di Carole Fréchette, adattato da Daniele Giampaolo, con la regia di Davide Raffaello Lauro e l’aiuto regia di Irene Latronico e l’interpretazione degli attori Gennaro Madonna, Niamh McCann e Flavio D’Andrea, in scena dal 19 al 21 maggio e poi dal 26 al 28 maggio.
I sette giorni di Simon Labrosse: alla ricerca di sé stessi
Siamo tutti un po’ Simon Labrosse. Nel mettere in scena sette giorni della vita di questo personaggio, Carole Fréchette parla del mondo attuale toccando temi come la speranza, l’incapacità scaturita dall’impossibilità di immaginare un futuro, l’incomunicabilità con il mondo esterno e il grido di disperazione insito nelle azioni che le nuove generazioni avanzano nei confronti di una società presente assente. Ma l’autrice lo fa senza alcun tipo di moralismo, senza avanzare argomentazioni preconfezionate. Anzi, in I sette giorni di Simon Labrosse quell’esistenza dell’essere umano contemporaneo – che in fin dei conti ci riguarda tutti, chi più chi meno, chi in un modo chi in un altro – è raccontata con ritmo, con ironia e soprattutto con sincerità disarmante, con quella verità spogliata dall’artificio illusorio.
Il lavoro proposto dai giovani attori del Théatre de Poche rende bene quanto un’opera come I sette giorni di Simon Labrosse sia calzante in pieno con i nostri tempi. Senza offrire nessuna operazione di adattamento troppo costruita, viene accentuata se possibile ancor di più l’ironia della penna di Fréchette finanche nell’esatto momento in cui a Simon Labrosse pare non rimanere altro che mettere in scena ossessivamente ed a tratti narcisisticamente la sua vita; così si crea un effetto ancor più potenziato di distacco da e di osservazione di una società che ci riguarda tutti, descritta nei valori, o meglio, nella mancanza di valori autentici. Da qui, il racconto di un presente assente e di conseguenza un’idea di futuro spaventosamente terribile nella sua apparente inguaribile instabilità, che porta Simon Labrosse a inventarsi i lavori più improbabili e più mal riusciti, ma non a caso tutti lavori che sottintendono il desiderio ardente di ascolto e di comunicazione della propria interiorità: per tutta la durata de I sette giorni di Simon Labrosse, il protagonista propone di diventare a pagamento uno stuntman emotivo, uno spettatore personale, un terminatore di frasi, un adulatore, un agitatore di coscienza e un destinatario di pacchi.
Queste che sono piccole realtà alla fine rivelano una straordinaria forza di resistenza. È interessante che giovani attori, drammaturghi e registi abbiano deciso di affrontare un testo come I sette giorni di Simon Labrosse, eppure ci pongono all’ascolto di una realtà della quale evidentemente dovremmo iniziare a prendere coscienza in modo più critico. Il disagio, talvolta spesso invalidante, della società odierna è un campanello d’allarme che suona sempre più vicino, estendendosi dalla politica, al lavoro e alla condizione esistenziale in cui ciascuno di noi versa, fino ai legami relazionali: tutto appare pregno di un pessimismo cupo, di una mancanza di prospettive concrete da parte di chi avrebbe il potere in mano ma lo sfrutta solo per una propaganda economica personale. Allora, siamo un po’ tutti quel Leo che si rintana nella sua caverna a scrivere poesie struggenti senza speranze, o quella Nathalie che si ostina ossessivamente a cercare la vita dentro di sé contro il marcio all’esterno, o quel Simon che decide eroicamente di vivere di sole speranze nell’attesa di risposte che mai giungeranno. Sono voci che vanno ascoltate quelle de I sette giorni di Simon Labrosse e quelli come il Théatre de Poche sono posti coraggiosi ai quali bisogna avvicinarsi, perché riuscire a cogliere il potenziale collettivo ed esistenziale di un’arte come il teatro, che forse più di tutte le arti da che il mondo è mondo ci narra, non è per niente da poco!
Fonte immagine: Ufficio stampa