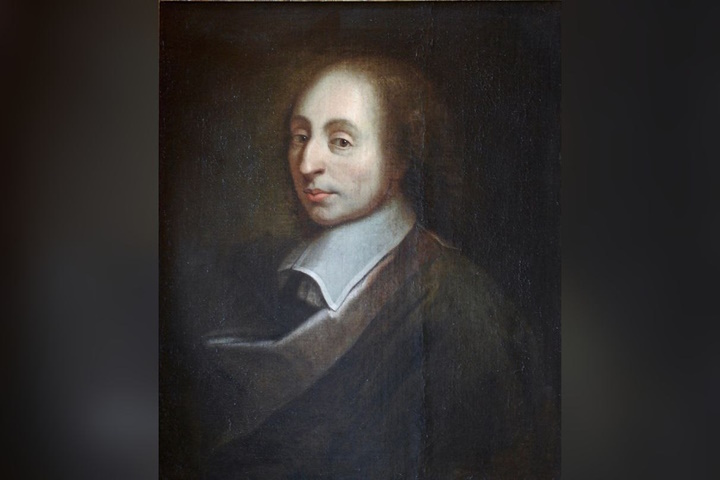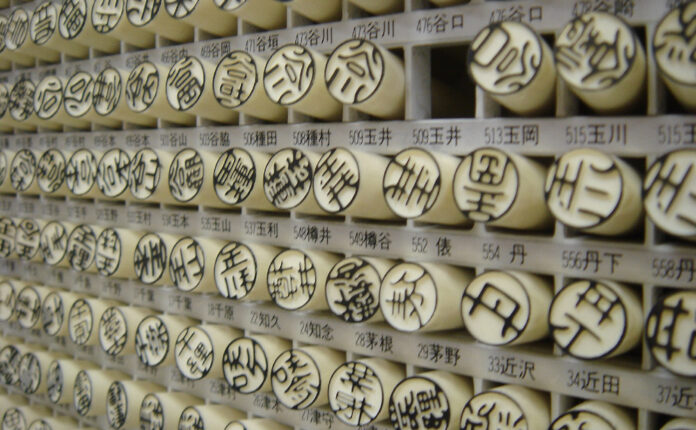Il libero arbitrio nella filosofia è un argomento centrale, che interroga la natura stessa della scelta umana. Dopo aver visto in generale cos’è il libero arbitrio, approfondiamo il dibattito filosofico. Il concetto postula che ogni persona abbia la facoltà di decidere liberamente le proprie azioni, basandosi unicamente sulla propria volontà. Le decisioni, quindi, non sarebbero il risultato di forze esterne, ma di un potere decisionale intrinseco all’individuo. A questa visione si contrappongono principalmente il determinismo e il concetto di destino.
Indice dei contenuti
Principali posizioni sul libero arbitrio
| Posizione filosofica | Principio chiave | Principali esponenti |
|---|---|---|
| Libertarismo | Il libero arbitrio è reale e incompatibile con il determinismo. Le nostre scelte non sono predeterminate. | Agostino d’Ippona, Cartesio, Immanuel Kant |
| Determinismo forte | Ogni evento, incluse le azioni umane, è la conseguenza necessaria di cause precedenti. Il libero arbitrio è un’illusione. | Democrito, Spinoza, Laplace |
| Compatibilismo | Il libero arbitrio e il determinismo possono coesistere. Si è liberi se si agisce secondo i propri desideri, anche se questi sono determinati. | Stoici, Hobbes, Hume |
Destino e determinismo: le forze esterne alla volontà
Sia nel destino che nel determinismo, le azioni umane sono viste come il prodotto di forze esterne. La differenza sta nella natura di queste forze:
- Determinismo: la forza esterna è la natura. Nulla avviene per caso, ma secondo un rapporto di causa-effetto. Il libero arbitrio non esiste perché ogni fenomeno ha una spiegazione fisica basata sul principio di causalità. Questa visione è stata fondamentale per lo studio economico di Karl Marx e per la psicoanalisi di Sigmund Freud.
- Destino (o fato): risalente alla filosofia stoica, postula una linea temporale prefissata per ogni uomo. La forza esterna è una volontà divina o soprannaturale. Per i romani, il fato era incarnato dalle Parche, mentre nell’antica Grecia dalle tre Moire, a cui persino gli dèi dovevano sottostare.
Come è stato affrontato il libero arbitrio nella storia della filosofia
Il concetto di libero arbitrio ha posto sfide in ambito etico, religioso e scientifico. Il dibattito ha attraversato i secoli.
La sintesi cristiana: Agostino e Tommaso
Con la teologia cristiana, lo sforzo fu quello di conciliare l’onnipotenza di Dio con la libertà umana. Agostino d’Ippona distinse la libertà (la capacità di realizzare i propri obiettivi) dal libero arbitrio (la facoltà di scegliere tra bene e male). Per Tommaso d’Aquino, invece, libero arbitrio e predestinazione non sono in conflitto, poiché entrambi tendono a un unico fine: Dio.
La Riforma e la negazione del libero arbitrio
Il dibattito si infiammò durante la Riforma. Martin Lutero, nel suo “De servo arbitrio”, affermò l’inesistenza del libero arbitrio: la salvezza o la dannazione dell’uomo sono già predestinate da Dio. A lui si oppose Erasmo da Rotterdam, sostenendo che le Sacre Scritture, con i loro ammonimenti e minacce di castighi, presuppongono la facoltà di scelta. Giovanni Calvino radicalizzò ulteriormente il concetto di predestinazione.
La svolta moderna: da Kant al dibattito contemporaneo
Con l’Illuminismo, il dibattito si sposta su un piano più laico. Per Immanuel Kant, il libero arbitrio è il fondamento stesso della moralità. La libertà non è semplice assenza di costrizioni, ma autonomia: la capacità della ragione di dare leggi a sé stessa. Un’azione è morale solo se è frutto di una scelta libera e razionale. Al contrario, filosofi come Spinoza sostennero un determinismo radicale, secondo cui il libero arbitrio è un’illusione dovuta alla nostra ignoranza delle cause che ci determinano. Come spiegato da fonti autorevoli come la Treccani, il dibattito oggi continua, arricchito dalle scoperte delle neuroscienze. Secondo voi, siamo liberi di scegliere o le nostre azioni sono il prodotto di cause che non controlliamo?
Fonte foto: freepik
Articolo aggiornato il: 19/09/2025