Il panismo è una percezione profonda che porta a una vera e propria fusione tra l’elemento umano e la natura. Il termine deriva dal greco παν (pan), che significa “tutto”, e si riferisce alla tendenza a confondersi e mescolarsi con il Tutto cosmico. In parole semplici, il panismo è quel sentimento che annulla i confini tra l’individuo e il mondo naturale, facendoli diventare un’unica entità vibrante.
Indice dei contenuti
Il panismo di D’Annunzio: la fusione superomistica
Gabriele D’Annunzio è certamente il poeta che meglio rappresenta questo concetto. Nella sua poetica, il panismo è uno strumento del superuomo per potenziarsi, attraverso un processo di “vegetalizzazione” dell’umano e di “antropomorfizzazione” della natura. Il poeta si immerge nel mondo naturale non per annullarsi, ma per assorbirne la forza vitale e affermare il proprio Io. Si tratta di una fusione sensoriale e fisica, in cui non vi è più distinzione tra il corpo del poeta e gli elementi naturali.
“La pioggia nel pineto”: l’esempio supremo del panismo dannunziano
Quale poesia di D’Annunzio esprime al meglio il panismo? Senza dubbio, “La pioggia nel pineto”, contenuta nella raccolta Alcyone. In questa celebre poesia, D’Annunzio e la sua amata Ermione, sorpresi dalla pioggia in una pineta, subiscono una vera e propria metamorfosi. I loro volti diventano “molli e silvani”, i loro capelli si trasformano in “ginestre”, in un processo che li rende parte integrante del bosco. Questa fusione non è solo spirituale, ma fisica, e permette al poeta-superuomo di vivere secondo un ritmo vitale superiore, confondendosi con la natura per dominarla esteticamente.
Il panismo in altri autori: Ungaretti e Pirandello a confronto
Sebbene associato principalmente a D’Annunzio, il concetto di panismo si ritrova, con significati diversi, anche in altri grandi autori del Novecento.
| Il Panismo in tre autori italiani | Scopo e Significato della fusione |
|---|---|
| Gabriele D’Annunzio (Alcyone) | È una fusione superomistica e sensuale. L’Io si espande per assorbire la vitalità della natura e potenziarsi. |
| Giuseppe Ungaretti (Allegria) | È una fusione esistenziale e salvifica. L’Io, fragile e precario, si immerge nella natura per ritrovare un senso di appartenenza e vincere la morte. |
| Luigi Pirandello (Uno, nessuno e centomila) | È una fusione filosofica e liberatoria. L’Io si dissolve nella natura per fuggire dalle “forme” e dalle maschere della società e ritrovare un’esistenza autentica. |
Il panismo esistenziale di Ungaretti
Che differenza c’è tra il panismo di D’Annunzio e quello di Ungaretti? In Giuseppe Ungaretti, in particolare nella raccolta Allegria, il panismo assume un significato quasi opposto. Non è l’affermazione di un Io divino, ma la ricerca di salvezza di un corpo fragile che “sottostà alla condizione del mondo”. Nella poesia I fiumi, il poeta si immerge nell’Isonzo per riscoprire le sue radici e sentirsi “una docile fibra dell’universo”. È un panismo salvifico, che permette all’uomo-soldato, precario come una foglia d’autunno, di trovare un legame con la vita e superare l’angoscia della morte.
Il panismo liberatorio di Pirandello
Anche in Luigi Pirandello, il panismo compare come via di fuga. Nel finale di Uno, nessuno e centomila, il protagonista Vitangelo Moscarda abbandona la società e se stesso per vivere immerso nella natura. La sua non è una fusione sensuale, ma un dissolvimento filosofico: “Muoio ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi”. È un modo per liberarsi dalle centomila maschere imposte dagli altri e vivere in un fluire continuo con il Tutto.
Le origini del concetto: il dio Pan
Il termine “panismo” deriva dal nome di Pan, dio della mitologia greca legato alla natura e alle sue forze selvagge. Figlio di Hermes, era il dio delle montagne, dei boschi e dei pastori. Spesso rappresentato con corpo d’uomo e zampe e corna di capro, era considerato un dio primitivo, capace di generare il “panico” con la sua apparizione. Il suo culto celebrava la forza istintiva e incontaminata del mondo naturale, la stessa forza in cui i poeti panici cercano di immergersi per attingere a una verità più profonda.
Immagine in evidenza per l’articolo sul panismo: Pixabay








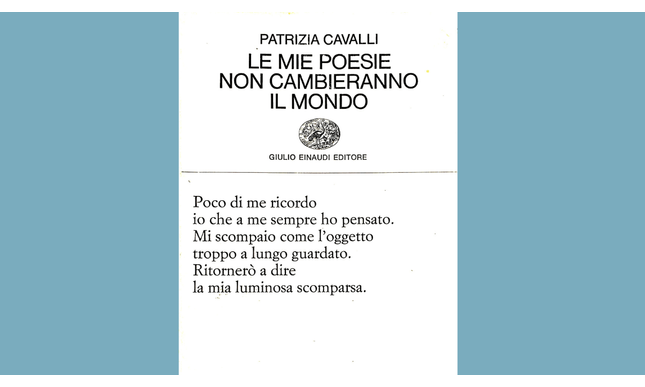



One Comment on “Cos’è il panismo: elementi e caratteristiche”