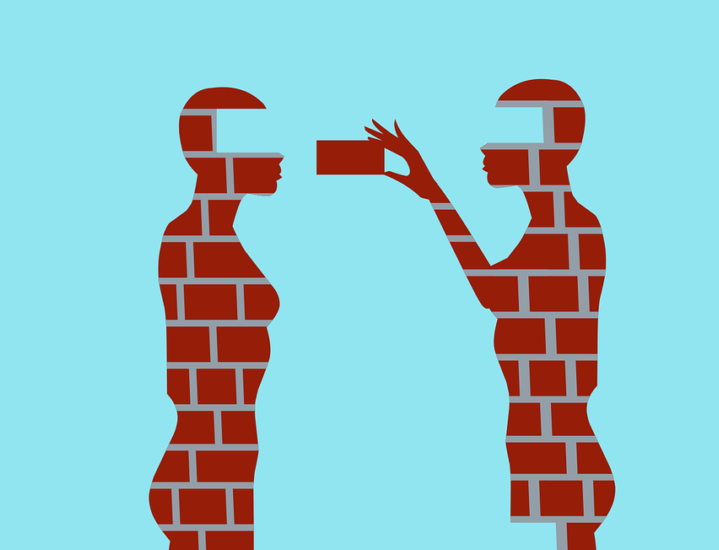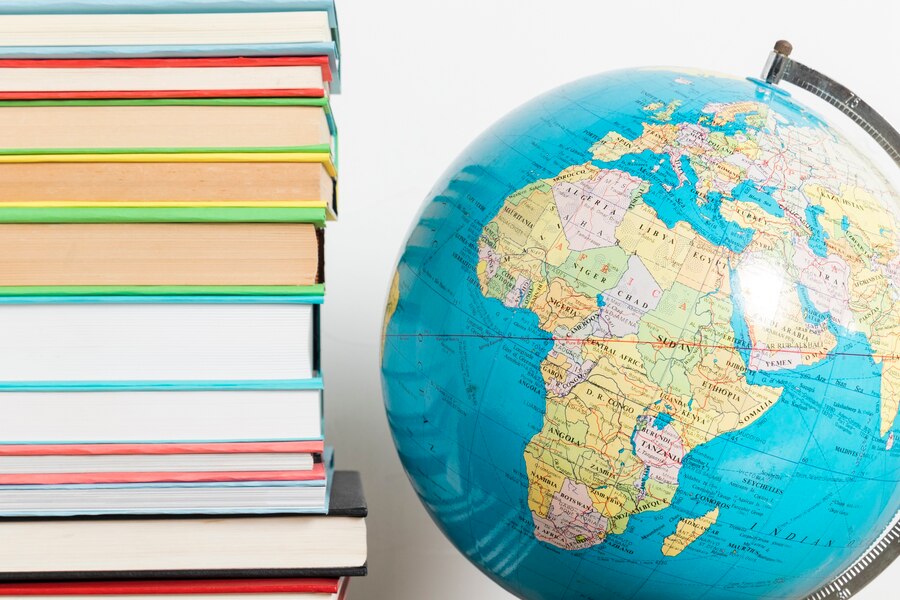Chi furono i primi pirati? Quando la pirateria infestava le acque del Mar Mediterraneo durante l’età classica
L’immagine stereotipata del pirata è la seguente: un criminale vissuto tra il XVII e il XVIII secolo nei Caraibi, armato di spada, con un pappagallo appoggiato sulla spalla, un bicchiere di rum in mano e (magari) anche un’occhio bendato, un uncino al posto della mano o una gamba di legno. La rappresentazione iconica proviene da personaggi letterari come John Silver de L’Isola del Tesoro (scritto da Robert L. Stevenson) o Capitan Uncino di Peter & Wendy (scritto da James Matthew Barrie), oppure cinematografici come i protagonisti della pentalogìa di Pirati dei Caraibi.
In realtà, la pirateria è un fenomeno piuttosto antico. Prima dei corsari e filibustieri nelle Antille, c’erano stati gli attacchi dei Vichinghi durante l’Alto Medioevo: le coste europee erano bersaglio degli invasori provenienti dai fiordi del Nord. Nel caso volessimo tornare più indietro, il Mar Mediterraneo aveva conosciuto gli attacchi di quelli che furono considerati i primi pirati nella storia occidentale.
Il vocabolo “pirata” (come riportato dal vocabolario Treccani) deriva dal latino pirata-ae; che a sua volta, deriva dal greco antico πειρατής, derivato dal verbo πειράω «tentare, assaltare».
I primi pirati del Mediterraneo, il caso delle fonti egizie
In un articolo pubblicato da Mark Woolmer sulla rivista Storica di National Geographic, lo storico afferma che i primi a parlare di attacchi di pirati furono gli Egizi durante il Nuovo Regno (la fase compresa tra il 1360 e il 1332 a.C.). I lukka e gli sheren sono i due gruppi di pirati menzionati nelle Lettere di Amarna, una serie di missive che i faraoni scambiavano con i sovrani dei regni alleati. Gli Egizi avevano messo in dubbio la fedeltà dei Ciprioti, ma essi negavano una possibile alleanza con i pirati mediterranei.
Gli attuali studiosi, secondo quanto riportato dal Dizionario di Storia dell’Enciclopedia Treccani, ritengono che i lukka e gli sheren non erano “bande di criminali”, piuttosto facevano parte dei “popoli del mare”. Si tratta di una definizione usata per indicare popolazioni ostili e bellicose provenienti dal Mediterraneo; esse giunsero in Egitto, Anatolia e Vicino Oriente tra il XIII e il XII secolo a.C., portando solo devastazioni e saccheggi.
Invasione dunque vi fu, e funse da fattore moltiplicatore per la crisi socioeconomica latente nel Mediterraneo orientale: i livelli di urbanizzazione e di aggregazione politica crollarono nell’Egeo, in Anatolia e nel Levante, e occorsero tre secoli per tornare a livelli analoghi a quelli del Tardo bronzo. L’invasione segna convenzionalmente il passaggio dall’Età del bronzo all’Età del ferro, con una complessa ristrutturazione socioeconomica, politica, territoriale e con l’adozione di nuove tecnologie (in particolare la metallurgia del ferro). Considerando che il moto migratorio travolse e coinvolse innanzi tutto il mondo miceneo, per spostarsi poi verso est, si pensa che la provenienza ultima fosse nella Penisola Balcanica. L’identificazione mediterranea dei vari popoli è in qualche caso ovvia (eqwesh = achei, lukka = lici), in altri ipotetica (sherdana = sardi?, shekelesh = siculi?, teresh = etruschi?). Lo stanziamento finale è noto per i filistei (costa palestinese), per i danuna (Cilicia), per gli zeker (tra filistei e fenici).
(Da Dizionario di storia, I popoli del mare, 2011)
La pirateria nell’Età classica: dal VI secolo allo scontro con Pompeo
Un notevole incremento della pirateria avvenne durante l’egemonia greca del Mediterraneo. Alla fine del VI secolo (l’età d’oro per la città di Atene), i mercanti greci operavano in un’area che andava dalle coste iberiche fino a quelle anatoliche, con incursioni nei territori lusitani e del Mar Nero. La pirateria era considerata una minaccia per i commercianti; anche se, era tollerata in quanto mezzo per il rifornimento di schiavi per il porto di Delo (il più grande mercato di schiavi dell’antichità che necessitava di “merce umana” per sostenere l’economia greca, basata anche sulla schiavitù). Soltanto Alessandro Magno provò a fermare i pirati. Dal momento che essi erano reputati una minaccia per il rifornimento di armi e alimenti per iniziare la sua campagna militare in Persia, il sovrano macedone provò a formare una colazione contro questi criminali. Dopo la sua morte nel 323 a.C., nessuna città-stato o sovrano si preoccupò del problema (aumentato con l’arrivo dei Cilici nelle acque mediterranee). Tra il III e il I secolo a.C. la pirateria era divenuta utile ai Romani e ai regni ellenistici per la grande necessità di schiavi.
Woolmer afferma che i pirati del Mediterraneo affrontarono i due uomini che avrebbero segnato il destino di Roma: Caio Giulio Cesare e Gneo Pompeo Magno. Il giovane Cesare fu rapito dai pirati e dopo la liberazione, il condottiero riunì una notevole armata e sconfisse i suoi sequestratori. Nel 67 a.C., Pompeo preparò una flotta romana per sconfiggere i pirati e le piratesse e ripulire le acque del Mediterraneo orientale dalla loro presenza (supportata da Mitridate, il re del Ponto). Lo storico greco Plutarco descrisse la resa di molti pirati con le seguenti parole:
Alcune delle bande dei pirati che erano ancora libere, ma che chiesero perdono, furono trattate umanamente [da Pompeo], tanto che, dopo il sequestro delle loro navi e la consegna delle persone, non gli fu fatto alcun male ulteriore; gli altri ebbero allora la speranza di essere perdonati, cercarono di scappare dagli altri comandanti e si recarono da Pompeo con le loro mogli e figli, arrendendosi a lui. Tutti questi furono risparmiati e, grazie al loro aiuto, furono rintracciati, sequestrati e puniti tutti coloro che erano ancora liberi nei loro nascondigli, poiché consapevoli di aver commesso crimini imperdonabili.
(Plutarco, Vita di Pompeo, 27.4.)
Immagine di copertina per “Chi furono i primi pirati?”: Pixabay