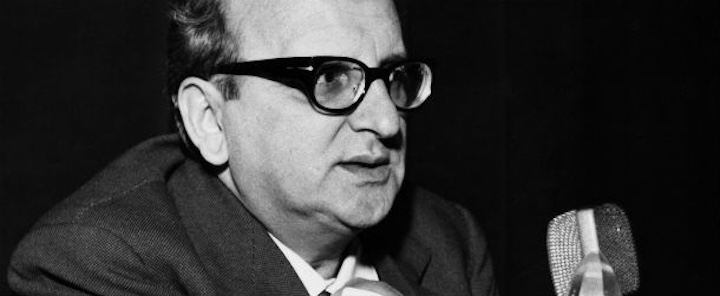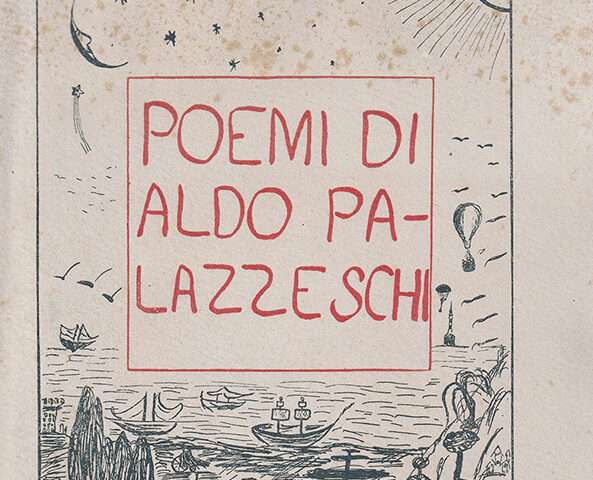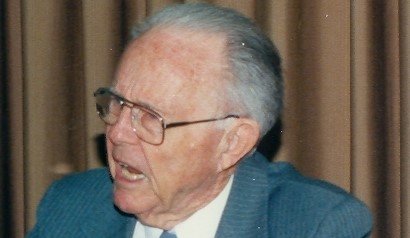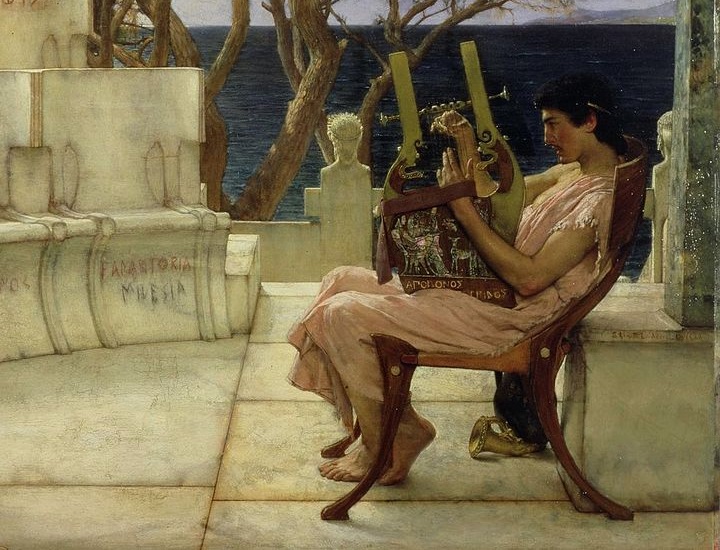Esistono numerose sottocategorie del genere fantascientifico. Tra queste, le distopie immaginano un futuro lontano con connotazioni negative, come in Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Esiste, però, un altro genere che, invece di guardare al futuro, si rivolge al passato per immaginarne uno diverso: l’ucronia.
Indice dei contenuti
Cos’è l’ucronia: definizione e caratteristiche
L’ucronia (o storia alternativa) è un genere narrativo basato sulla premessa: “E se…?“. Cosa sarebbe successo se un evento storico fosse andato diversamente? Il termine, come riportato da fonti autorevoli come l’Enciclopedia Treccani, fu coniato dal filosofo francese Charles Renouvier nel 1876 e deriva dal greco οὐ (non) e χρόνος (tempo), significando letteralmente “nessun tempo”, un tempo che non esiste. Le opere ucroniche partono da un punto di divergenza (POD, Point of Divergence), un momento in cui la storia reale e quella immaginaria si separano, creando un mondo alternativo.
Le origini del genere: da tito livio a napoleone
Il primo esempio di speculazione ucronica risale a un passo dell’opera Ab Urbe Condita dello storico Tito Livio. Nel nono libro, egli si interroga su cosa sarebbe successo se Alessandro Magno avesse deciso di conquistare Roma. Nel corso dei secoli, molti autori hanno analizzato scenari simili. Louis Geoffroy, in Napoleone apocrifo (1836), immagina il successo della campagna di Napoleone in Russia. Lorenzo Pignotti, nella sua Storia della Toscana (1813), ipotizza un’Italia diversa se Lorenzo de’ Medici non fosse morto prematuramente nel 1492.
La seconda guerra mondiale: un fertile terreno ucronico
La Seconda Guerra Mondiale è l’evento storico più utilizzato come punto di divergenza. Molti autori hanno immaginato cosa sarebbe successo se l’Asse avesse vinto la guerra. Uno dei romanzi più celebri è La svastica sul sole (The Man in the High Castle) di Philip K. Dick, che descrive un mondo spartito tra Germania nazista e Impero giapponese. Un’altra visione è quella di Robert Harris in Fatherland, un thriller ambientato in una Berlino capitale di un Reich vittorioso. Anche autori italiani come Mario Farneti si sono cimentati con il tema, immaginando un’Italia fascista neutrale e divenuta una potenza mondiale.
Esempi celebri di ucronia: dal libro al videogioco
| Esempi celebri di ucronia: dal libro al videogioco | ||
|---|---|---|
| Opera | Punto di divergenza (pod) | Mondo alternativo risultante |
| La svastica sul sole (libro/serie tv) | Le potenze dell’asse vincono la seconda guerra mondiale. | Gli stati uniti sono divisi in due zone di occupazione, una tedesca e una giapponese. |
| Fallout (videogioco) | La tecnologia a transistor non viene inventata, portando a un’era atomica prolungata. | Un’america retro-futuristica anni ’50 che culmina in una guerra nucleare globale. |
| Bastardi senza gloria (film) | Un complotto per assassinare i leader nazisti ha successo. | Hitler e i vertici del reich vengono uccisi in un cinema a parigi, ponendo fine alla guerra. |
| Watchmen (fumetto) | L’esistenza di supereroi reali altera il corso del XX secolo. | Gli stati uniti vincono la guerra del vietnam e nixon viene rieletto più volte. |
Ucronia: una riflessione sul presente
L’ucronia non è solo un genere di intrattenimento, ma anche uno strumento di riflessione sulla storia. Ci invita a considerare come il corso degli eventi sia determinato da scelte e circostanze, e come il mondo in cui viviamo sia solo una delle tante possibilità. L’ucronia ci ricorda che la storia non è un percorso lineare e immutabile, ma un intreccio di possibilità, e che il presente è il risultato di una serie di eventi che avrebbero potuto prendere direzioni diverse.
Articolo aggiornato il: 15/09/2025