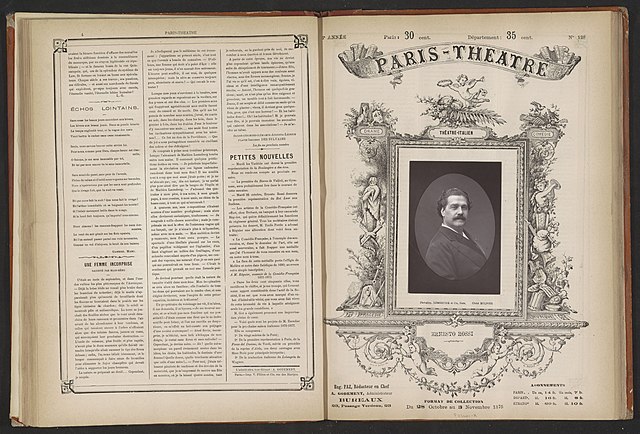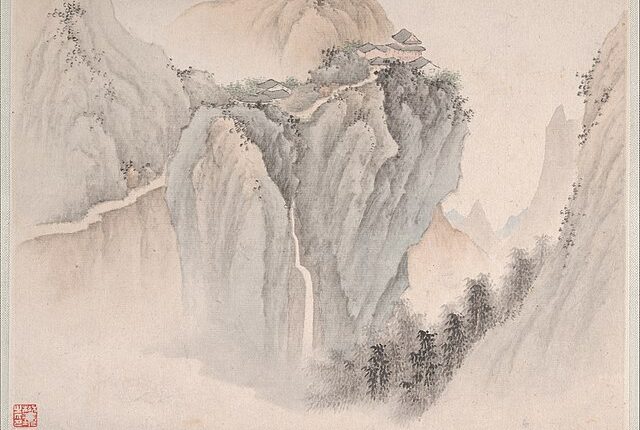Mos Maiorum: significato, valori e importanza nell’antica Roma
Il Mos Maiorum rappresentava il nucleo fondante della civiltà romana, l’insieme dei valori, delle tradizioni e dei costumi che definivano l’identità stessa di Roma e dei suoi cittadini. Nell’Antica Roma, questo concetto, letteralmente traducibile come “costumi degli antenati”, costituiva la spina dorsale della società, un codice non scritto ma profondamente radicato nella coscienza collettiva. Idealizzando i costumi dei Padri, il Mos Maiorum si ispirava ai valori dell’antica società romana, quella arcaica e agricola, e fungeva da modello di comportamento per ogni cives, il cittadino romano. Era una sorta di bussola morale che orientava la vita pubblica e privata, un faro che illuminava il cammino verso la virtù e il bene comune.
Cosa si intende per Mos Maiorum?
L’espressione Mos Maiorum, letteralmente “i costumi dei Padri”, racchiude in sé il patrimonio valoriale della civiltà romana. Si tratta di un insieme di principi morali, etici, religiosi, sociali e politici che costituivano il fondamento della vita del cives romanus. Questi valori, tramandati di generazione in generazione, rappresentavano la summa della saggezza e dell’esperienza accumulata dagli antenati, un’eredità preziosa da custodire e preservare. Il Mos Maiorum, dunque, identificava il bagaglio culturale, etico e morale a cui ogni vir romano doveva ispirarsi per mantenere integra la propria identità e la propria levatura morale.
Il carattere identitario di ogni cives romanus era strettamente legato al valore collettivo degli antiqui mores (i costumi antichi). Questo legame generava una forte consapevolezza identitaria individuale e collettiva, un senso di appartenenza a una comunità unita da valori condivisi e da un comune destino. Ogni bonus cives, ogni buon cittadino, si sentiva parte di un tutto più grande, di una storia millenaria che affondava le sue radici in un passato glorioso e ricco di esempi virtuosi.
Quando nasce?
Secondo le opere storico-giuridiche di Gaio e Sesto Pomponio, i mores, ovvero gli usi e i costumi delle tribù che si unirono per fondare la città di Roma, rappresentavano la base primordiale del diritto romano. In questa fase iniziale, erano i mores a costituire l’essenza del diritto, servendo come modello di comportamento per i membri della comunità. Questi modelli erano il risultato di secoli di usanze che risalivano ai tempi delle tribù rurali, note come pagi. Gli studiosi ritengono che in un periodo precedente all’età regia, durante la fase pre-civica, i mores si basassero sul comportamento delle familiae e, successivamente, a partire dalla metà dell’VIII secolo a.C., anche delle gentes. Questi comportamenti rispecchiavano il rispetto per le forze naturali e venivano interpretati dai sacerdoti, i Pontifices, che li tramandavano oralmente e custodivano segretamente in archivi sacerdotali.
Inizialmente, i mores non costituivano leggi formali ma piuttosto precetti unanimemente condivisi ed esercitati dalla comunità, specialmente nell’ambito della Roma precivica. Verso il X secolo a.C., i sacerdoti raccoglievano questi usi sia oralmente che, probabilmente, per iscritto, mantenendoli segreti. A quel tempo, erano gli unici detentori delle conoscenze giuridiche, e una delle loro responsabilità era quella di svelare, in modo sempre riservato, questi usi a chi li richiedeva o interpretarli secondo la loro discrezione. Questi consigli erano volti a guidare il richiedente verso una condotta che favorisse i propri interessi legittimi o a consentire una difesa adeguata dei propri diritti, in un’epoca in cui il diritto era ancora fortemente permeato da una forte componente morale e dal rispetto di determinate ritualità nelle dichiarazioni, nei comportamenti e, in generale, nell’agire sociale, sia in ambito pubblico che privato. Queste modalità continuarono ad essere rilevanti sia durante il periodo regio che in buona parte dell’era repubblicana. Durante l’età regia, l’interpretazione di tali usi era affidata al rex e al Pontifex Maximus, talvolta in collaborazione.
La concezione di Stato
Il codice comportamentale prescritto dal Mos Maiorum poneva al centro il bene comune, la Res Publica. Il bene del singolo cittadino era strettamente intrecciato al bene di tutti i cittadini; per questo, uno dei valori cardine del Mos Maiorum era proprio il rispetto e la dedizione alla Res Publica.
Per Res Publica romana (traducibile come “la cosa pubblica”, la Repubblica) si intende il patrimonio ideale e materiale del popolo romano, il bene comune della società, il cui interesse era considerato preminente rispetto all’interesse individuale. Era un concetto che abbracciava non solo le istituzioni e le leggi, ma anche i valori, la cultura e il destino stesso di Roma.
Lo Stato era concepito come un’entità viva, animata dall’alto senso civico del popolo romano. Ogni cives romanus, in virtù di questo profondo senso civico, contribuiva attivamente al buon governo attraverso la partecipazione alla vita pubblica e il rispetto delle manifestazioni virtuose del Mos Maiorum. I cittadini non erano semplicemente sudditi, ma membri attivi e responsabili della comunità, chiamati a difendere e promuovere il bene comune.
Mos Maiorum: i sentimenti patrii
Il Mos Maiorum si articolava in una serie di qualità e sentimenti che ogni probus vir e optimus cives, ogni uomo onesto e cittadino esemplare, doveva possedere e coltivare. Tra questi valori, possiamo ricordare, a titolo esemplificativo:
Abstinentia (onestà e integrità nei confronti dell’amministrazione pubblica); frugalitas (sobrietà d’animo); aequitas, iustitia, honestas (uguaglianza, giustizia, onestà); beneficentia, benignitas, liberalitas, magnanimitas (beneficenza, bontà, liberalità morale e magnanimità politica); pietas, probitas, pudor (pietà, probità, pudore); urbanitas, decorum, elegantia (cortesia, decoro, raffinatezza); gravitas, exemplum, consilium (serietà, capacità di essere d’esempio, saggezza); constantia, fortitudo, fides, virtus (costanza, forza morale, lealtà, virtù d’animo e militare); clementia, temperantia, humanitas, continentia, modus (clemenza, temperanza, umanità, continenza, moderazione); officium, religio (senso del dovere sociale e sentimento religioso); auctoritas, gloria, honor, libertas (prestigio, gloria, onore, libertà dell’animo incorrotto).
Gli ideali di virtus e fortitudo
Per comprendere appieno lo spirito del Mos Maiorum, è utile analizzare due passi emblematici, tratti rispettivamente dal De vita beata di Seneca e dalle Noctes Atticae di Gellio, che trattano gli ideali di virtus e fortitudo:
«[…] Cum tibi dicam: «Summum bonum est infragilis animi rigor et providentia et sublimitas et sanitas et libertas et concordia et decor», aliquid etiamnunc exigis maius ad quod ista referantur? Quid mihi voluptatem nominas? Hominis bonum quaero, non ventris, qui pecudibus ac beluis laxior est […]»;
«[…] Fortitudo autem non ea est, quae contra naturam monstri vicem nititur ultraque modum eius egreditur aut stupore animi aut inmanitate […] sed ea vera et proba fortitudo est, quam maiores nostri scentiam esse dixerunt rerum tolerandarum et non tolerandarum. Per quod apparet esse quaedam intolerabilia, a quibus fortes viri aut obeundis abhorreant aut sustinendis […]».
Questi passi evidenziano come la virtus non risieda nella ricerca del piacere materiale, ma nella forza d’animo, nella saggezza, nella libertà interiore e nella concordia. La fortitudo, a sua volta, non è intesa come una forza bruta o innaturale, ma come la capacità di discernere ciò che è giusto e sopportabile da ciò che non lo è, un concetto che rispecchia l’equilibrio e la moderazione tanto cari al Mos Maiorum. Essa si manifestava sia in ambito militare che nella vita quotidiana, come capacità di affrontare le avversità con coraggio e dignità.
La decadenza del Mos Maiorum e le sue conseguenze
La decadenza del Mos Maiorum fu un tema ampiamente trattato da storici antichi come Sallustio. Questo autore romano del I secolo a.C., noto per le sue opere storiche e politiche, descrisse dettagliatamente la crescente corruzione e la perdita dei valori tradizionali nella società romana del suo tempo, in particolare con la diffusione dell’ellenismo e della cultura greca. Sallustio attribuì questa decadenza principalmente alla ricchezza e al potere eccessivo che avevano corrotto le élite romane, i patrizi, contrapposti ai plebei che spesso mantenevano i valori tradizionali. La lussuria, l’avidità e l’egoismo avevano soppiantato le virtù tradizionali come la temperanza, la clemenza e il senso del dovere verso la Repubblica. Questa decadenza morale, secondo lo storico, portò a una serie di conseguenze devastanti per la società romana, tra cui la discordia politica, la disintegrazione dell’unità civica e, alla fine, alla rovina della Repubblica romana stessa, con lotte sociali e guerre civili. In effetti, la perdita del Mos Maiorum e dei suoi valori fondamentali, più volte sottolineata anche da autori come Catone il Censore, Cicerone, Livio, Tacito e Polibio, contribuì in modo significativo alla crisi della Repubblica che avrebbe portato all’ascesa dell’Impero romano e alla fine della Repubblica.
Fonte immagine di copertina per l’articolo Mos Maiorum: cos’è, principi, significato e valori: Wikipedia