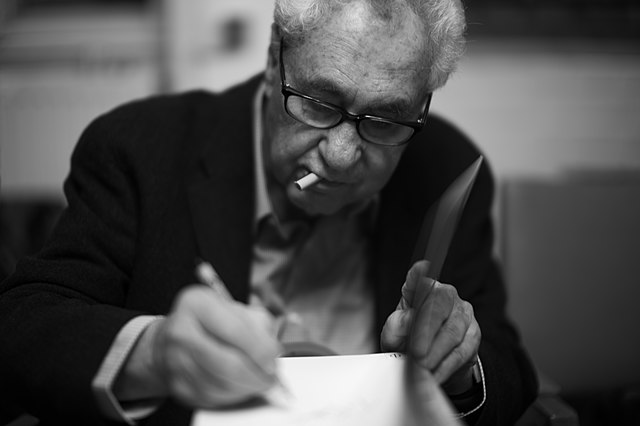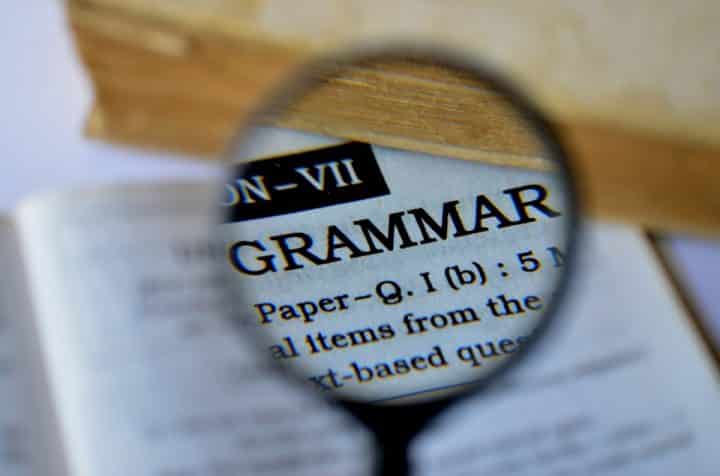Tra il XII e il XIII secolo si diffuse in Europa una visione inedita del cristianesimo, concepita come una lotta eterna tra bene e male che aveva l’uomo come campo di battaglia. Si trattava dell’eresia catara, uno dei movimenti ereticali più noti del Medioevo, il cui finale tragico, segnato dalla crociata contro gli Albigesi, cambiò per sempre il volto della Chiesa.
Indice dei contenuti
- 1. L’origine del nome: da “puri” a “Albigesi”
- 2. Il credo cataro: un dualismo tra bene e male
- 3. La società catara: Perfetti, Credenti e il rito del Consolamentum
- 4. La diffusione in Occitania e il legame con i trovatori
- 5. La crociata contro gli Albigesi: “Uccideteli tutti”
- 6. La fine dei catari: l’assedio di Montségur e l’Inquisizione
L’origine del nome: da “puri” a “Albigesi”
L’origine del termine “cataro” è molto discussa. Una delle teorie più accreditate fa risalire la parola al greco katharòs, che significa “puro”, termine già usato negli atti del Concilio di Nicea. Una teoria più dispregiativa, usata dai detrattori, lo fa invece derivare dal latino medievale cattus, “gatto”, animale considerato un simbolo di Lucifero.
I catari erano poi conosciuti con altri nomi, a seconda dei luoghi in cui si diffuse l’eresia: “Albigesi” dalla città di Albi, uno dei loro centri principali, “Tolosani” da quella di Tolosa, e in Italia anche “Patarini”.
Il credo cataro: un dualismo tra bene e male
Alla base dell’eresia catara vi era un concetto dualistico, influenzato da antiche dottrine come il manicheismo, giunte in Europa tramite i contatti con l’Impero Bizantino durante le Crociate. I catari sostenevano l’esistenza di due principii opposti e in perenne lotta: il Bene (il Dio del Nuovo Testamento, creatore degli spiriti) e il Male (il Satana dell’Antico Testamento, creatore del mondo materiale).
Il corpo umano, essendo materia, era considerato una prigione creata dal maligno per intrappolare l’anima, la scintilla divina. L’obiettivo della vita era quindi la liberazione dello spirito attraverso una vita ascetica basata sugli insegnamenti di Gesù, visto come un angelo puro inviato per mostrare la via della salvezza, e non come un essere di carne e ossa.
| Credo Cataro | Dottrina Cattolica |
|---|---|
| Dualismo: due Dèi, uno del Bene (spirito) e uno del Male (materia). | Monoteismo: un solo Dio creatore di tutto, visibile e invisibile. |
| Gesù: un angelo, puro spirito, la cui crocifissione fu solo apparente. | Gesù: Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto fisicamente. |
| Sacramenti: rifiutati perché materiali. L’unico rito è il Consolamentum. | Sette Sacramenti: (Battesimo, Eucaristia, etc.) sono veicoli della grazia divina. |
| Procreazione: vista negativamente, poiché intrappola nuove anime in corpi materiali. | Matrimonio: un sacramento finalizzato alla procreazione. |
La società catara: Perfetti, Credenti e il rito del Consolamentum
I seguaci del catarismo erano divisi in due categorie: i Perfetti (perfecti) e i Credenti (credentes).
- I Perfetti erano una minoranza ascetica che viveva in povertà assoluta, castità e seguiva una dieta vegana (ad eccezione del pesce, considerato “puro”). Essi amministravano l’unico sacramento cataro, il Consolamentum.
- I Credenti, detti anche Boni Homines (uomini buoni), costituivano la maggioranza. Non erano tenuti a seguire i rigidi precetti, ma sostenevano i Perfetti e aspiravano a ricevere il Consolamentum in punto di morte per garantire la salvezza della propria anima.
Il Consolamentum era il battesimo dello Spirito Santo, impartito non con l’acqua ma con l’imposizione delle mani e del libro del Vangelo di Giovanni sulla testa del fedele.
La diffusione in Occitania e il legame con i trovatori
L’eresia catara si diffuse soprattutto in Italia Settentrionale e in Occitania (Francia meridionale), facendo breccia nei poveri ma anche tra i nobili, affascinati dalla purezza del loro messaggio e interessati a indebolire il potere della Chiesa. L’Occitania del XII secolo era una regione culturalmente vibrante e politicamente frammentata, terreno fertile per nuove idee. Qui fiorì la lingua d’oc e la lirica dei trovatori, la cui esaltazione della donna e dell’amore spirituale (fin’amor) presentava affinità con la visione catara, che riconosceva alle donne un ruolo attivo nella comunità religiosa.
La crociata contro gli Albigesi: “Uccideteli tutti”
La Chiesa guardava con crescente allarme al movimento cataro. Dopo tentativi falliti di repressione tramite la predicazione, papa Innocenzo III decise di passare alle maniere forti. L’occasione si presentò il 14 gennaio 1208, quando un legato pontificio fu assassinato da un uomo al servizio del conte Raimondo VI di Tolosa, protettore dei catari. Il pontefice bandì allora una crociata, la prima in territorio europeo contro altri cristiani, promettendo le terre degli eretici ai nobili del nord della Francia.
La crociata contro gli Albigesi (1209-1229) fu un conflitto di una brutalità inaudita. Durante il massacro di Béziers (1209), si narra che al legato pontificio Arnaud Amaury, quando un soldato chiese come distinguere gli eretici dai cattolici, egli rispose con la celebre frase: “Uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi”. Sebbene l’autenticità della frase sia dibattuta, essa riassume perfettamente la ferocia della repressione.
La fine dei catari: l’assedio di Montségur e l’Inquisizione
La spedizione militare si concluse nel 1229 con la sottomissione dei signori del sud alla corona francese, ma la resistenza catara continuò. L’ultimo grande atto della tragedia si consumò nella fortezza di Montségur, considerata il rifugio degli ultimi Perfetti. Dopo un assedio di dieci mesi, il 16 marzo 1244, oltre duecento catari che rifiutarono di abiurare furono arsi vivi in un immenso rogo ai piedi del castello.
I sopravvissuti furono braccati dal Tribunale dell’Inquisizione, istituito da papa Gregorio IX. Chi si pentiva veniva umiliato pubblicamente, costretto a portare croci gialle cucite sugli abiti o a subire frustate. Chi rifiutava di sottomettersi veniva condannato al rogo. L’eresia catara, con la sua repressione, aveva mostrato il volto più oscuro di una Chiesa disposta a usare la violenza pur di mantenere la propria autorità spirituale e temporale.
Oggi i castelli catari, come Montségur e Carcassonne, sono una potente testimonianza storica e una meta turistica. È possibile visitare il castello di Montségur, situato nel dipartimento dell’Ariège, per rivivere uno dei capitoli più drammatici della storia medievale.
Immagine di copertina: SanMarco Pop
Ultimo aggiornamento: 23 agosto 2025