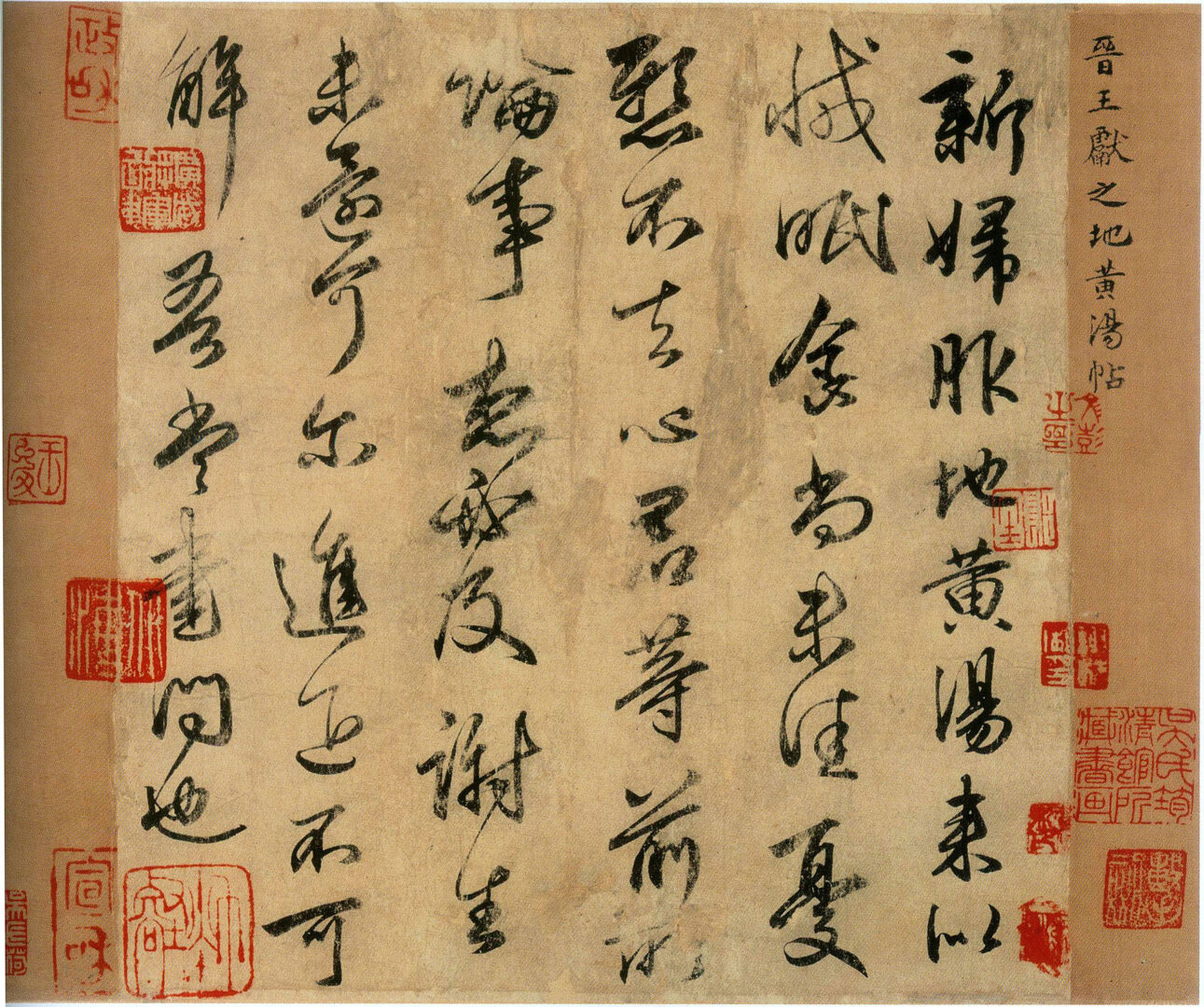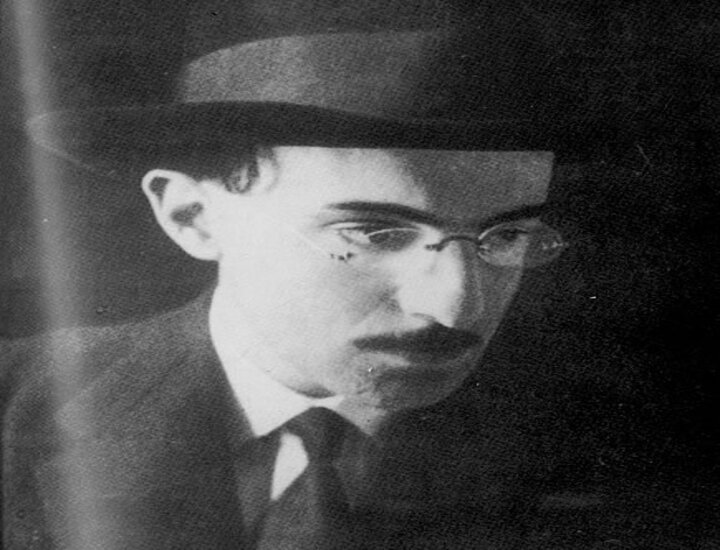I popoli senza stato sono nazioni o gruppi etnici con una forte identità culturale e storica a cui non corrisponde uno stato sovrano e indipendente riconosciuto a livello internazionale. Sebbene la Convenzione di Montevideo del 1933 definisca uno stato sulla base di un territorio, una popolazione, un governo e la capacità di avere relazioni internazionali, milioni di persone appartengono a nazioni che non soddisfano questi criteri, vivendo come minoranze spesso perseguitate.
È fondamentale distinguere tra “popolo senza stato” e “apolide”. Un apolide è un individuo a cui nessuno stato riconosce la cittadinanza, come definito dalla Convenzione di New York del 1954. Un popolo senza stato, invece, è un’intera collettività che condivide una lingua e una cultura, ma non ha un proprio territorio statale. Mentre l’ONU riconosce 193 stati sovrani, la lotta per l’autodeterminazione di molte nazioni continua a essere una delle questioni geopolitiche più complesse e drammatiche.
Indice dei contenuti
I principali popoli senza stato a confronto
Per fornire un quadro chiaro, questa tabella riassume la situazione di alcuni dei più noti popoli senza stato, evidenziando le aree geografiche e il contesto della loro lotta per il riconoscimento.
| Popolo | Contesto e area geografica |
|---|---|
| Curdi | La più grande nazione senza stato, divisa tra Turchia, Siria, Iraq e Iran. Lottano per un Kurdistan indipendente da oltre un secolo. |
| Palestinesi | Popolo arabo che rivendica uno stato indipendente nei territori palestinesi (Cisgiordania e Striscia di Gaza), occupati da Israele dal 1967. |
| Rohingya | Minoranze etnica musulmana del Myanmar a cui è negata la cittadinanza. Vittime di una pulizia etnica che ha causato un esodo di massa. |
| Uiguri | Popolazione turcofona di religione musulmana che vive nella regione dello Xinjiang, in Cina, soggetta a una sistematica repressione culturale e religiosa. |
Il caso dei curdi: una nazione divisa tra più stati
Il popolo curdo è uno degli esempi più emblematici di nazione senza stato. Dopo la dissoluzione dell’Impero Ottomano, il Trattato di Sèvres (1920) prevedeva la creazione di un Kurdistan autonomo, ma il successivo Trattato di Losanna (1923) cancellò questa promessa, dividendo il loro territorio tra Turchia, Iran, Iraq e Siria. Da allora, i curdi hanno subito politiche di assimilazione forzata e brutale repressione, in particolare in Turchia sotto Mustafa Kemal Atatürk e in Iraq sotto Saddam Hussein, che utilizzò armi chimiche contro di loro durante il massacro di Halabja nel 1988.
Nonostante le persecuzioni, la lotta per l’autonomia non si è mai fermata. Movimenti come il Partito Democratico del Kurdistan (PDK) in Iraq e il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) in Turchia (considerato un’organizzazione terroristica da Turchia, USA e UE) hanno mantenuto viva la causa. L’unica entità politica semi-indipendente è la Regione del Kurdistan nel nord dell’Iraq, riconosciuta come regione federale autonoma dopo il 2003. Più di recente, i curdi siriani hanno stabilito un’amministrazione autonoma nel Rojava, ma la loro esistenza è costantemente minacciata dall’ostilità della Turchia di Erdoğan.
La Palestina e la questione dello stato negato
La questione palestinese è radicata nel conflitto tra il nazionalismo arabo e il movimento sionista, emerso alla fine del XIX secolo. Dopo la Prima Guerra Mondiale, il crollo dell’Impero Ottomano e il Mandato Britannico sulla Palestina, la Dichiarazione Balfour (1917) appoggiò la creazione di un “focolare nazionale per il popolo ebraico”. La situazione si intensificò dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1947, la Risoluzione 181 dell’ONU propose la spartizione della Palestina in due stati, uno arabo e uno ebraico. La leadership araba rifiutò il piano, e la successiva proclamazione dello Stato di Israele nel 1948 portò alla prima guerra arabo-israeliana e alla “Nakba” (la catastrofe), l’esodo forzato di oltre 700.000 palestinesi.
Da allora, nonostante numerosi tentativi diplomatici come gli Accordi di Oslo (1993), la creazione di uno stato palestinese sovrano è rimasta irrealizzata. I palestinesi vivono in una condizione di occupazione militare israeliana in Cisgiordania e sotto blocco nella Striscia di Gaza, con continue violazioni dei diritti umani documentate da organizzazioni come Human Rights Watch. Ad oggi, la Palestina è riconosciuta come Stato osservatore non membro dall’ONU, ma non come membro a pieno titolo.
I rohingya: un genocidio silenzioso in Myanmar
I Rohingya sono una minoranza etnica musulmana che vive da secoli nello stato di Rakhine, in Myanmar, un paese a maggioranza buddista. Considerati immigrati illegali dal Bangladesh, sono vittime di una persecuzione sistematica. La legge sulla cittadinanza del 1982 li ha ufficialmente resi apolidi, escludendoli dalla lista delle 135 etnie riconosciute e negando loro i diritti fondamentali come l’accesso all’istruzione, alla sanità e alla libertà di movimento.
La violenza contro i Rohingya è culminata nel 2017 con operazioni militari di una brutalità tale che le Nazioni Unite hanno parlato di “un esempio da manuale di pulizia etnica” e di atti con “intento genocida”. Villaggi interi sono stati rasi al suolo e oltre 740.000 persone sono fuggite in Bangladesh, dove vivono in campi profughi sovraffollati. La situazione, come documentato costantemente dall’UNHCR, rimane una delle più gravi crisi umanitarie del nostro tempo.
Gli uiguri e la repressione nello Xinjiang
Gli Uiguri sono una popolazione turcofona di religione musulmana sunnita, concentrata principalmente nella Regione Autonoma dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina. Sebbene la regione sia formalmente autonoma, Pechino ha sempre esercitato un controllo ferreo, intensificatosi drasticamente negli ultimi anni. Con la motivazione di combattere “terrorismo, estremismo e separatismo”, il governo cinese ha messo in atto una campagna di repressione di massa.
Numerose inchieste internazionali hanno rivelato l’esistenza di “campi di rieducazione” in cui si stima che oltre un milione di uiguri e altre minoranze musulmane siano stati detenuti illegalmente. All’interno di questi campi, i prigionieri sono sottoposti a indottrinamento politico, lavoro forzato, sterilizzazioni e alla cancellazione sistematica della loro identità culturale e religiosa. Questa situazione è stata definita da molti governi e organizzazioni per i diritti umani come un genocidio culturale.
Fonte dell’immagine: Pixabay
Articolo aggiornato il: 18/10/2025